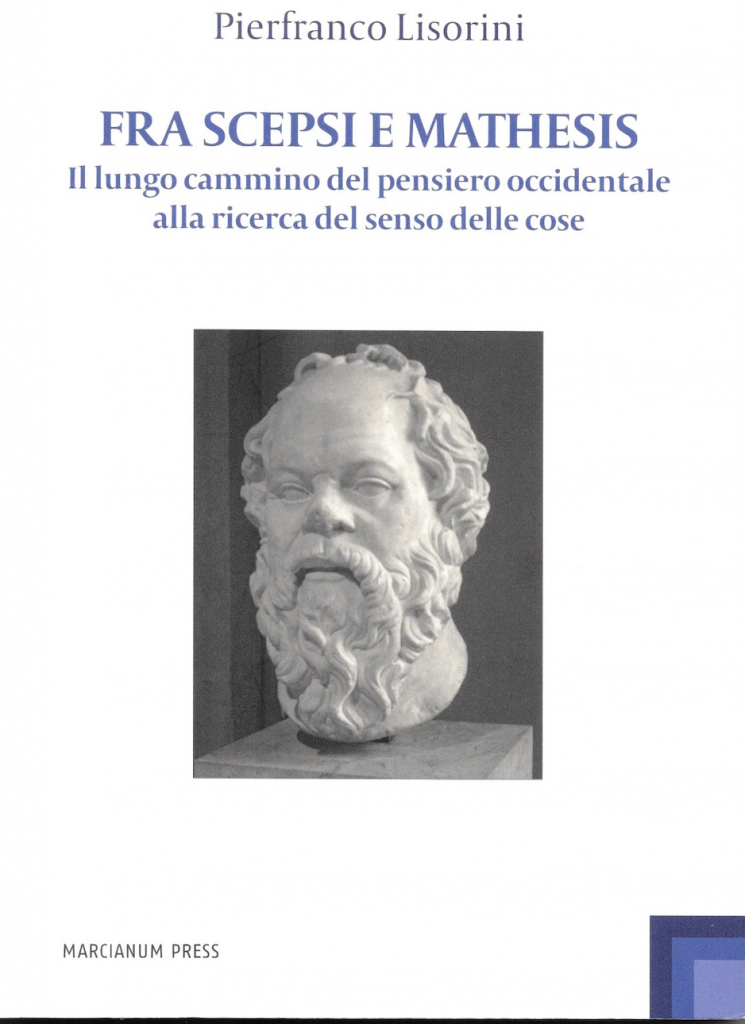Le due Italie separate dal fossato dell’ignoranza e dell’apatia
Prima o poi l’Italia dovrà fare pace con se stessa, riprendere nelle sue mani la propria storia e imparare a porsi di fronte al mondo come l’erede della romanità e della civiltà comunale e rinascimentale, depositaria di un patrimonio culturale che non ha cessato di arricchirsi dall’antichità al ventesimo secolo e non ha uguali nel mondo. Non dirò che quello italiano è un grande popolo al quale manca la consapevolezza della propria grandezza: sarebbe cattiva retorica e, per quel che mi riguarda, ipocrisia perché ho una pessima opinione dei miei compatrioti. Dico che l’Italia è un grande Paese del quale gli italiani rischiano di non essere degni: un tragico paradosso che trova conferma nella sciatteria, nella volgarità, nell’ignoranza che ci circondano e ci soffocano.
 E che non appartengono solo ai ceti subalterni condannati all’invidia sociale e alla marginalità da una scuola che ha perso la sua funzione di riequilibratore sociale e di veicolo di valori identitari ma riflettono i modelli di riferimento, la moda, il linguaggio, gli stili di vita di un’immagine di Paese tanto più sconfortante quanto più si sale nella scala sociale. Scrittori di successo, grandi firme del giornalismo, leader politici, guitti, giocatori di calcio, manager e imprenditori si mescolano all’interno di una nuova torpida formazione sociale al vertice di quella scala che infetta tutta la nazione. So bene che in molti campi ci sono italiani che continuano a dare al mondo il contributo della loro intelligenza e del loro genio creativo ma proprio loro sono la migliore conferma della gravità dell’infezione perché nessuno di loro è espressione del nostro Paese: o sono cresciuti all’estero dove hanno trovato l’opportunità per farsi valere o sono scappati dall’Italia in cerca di aria fresca e quelli che vi rimangono sono corpi estranei, scontenti e delusi; in ogni caso non hanno niente a che fare con quella formazione sociale e col gruppo di potere che ha condannato l’Italia alla subalternità e l’ha ridotta al proprio livello di miseria morale culturale e intellettiva.
E che non appartengono solo ai ceti subalterni condannati all’invidia sociale e alla marginalità da una scuola che ha perso la sua funzione di riequilibratore sociale e di veicolo di valori identitari ma riflettono i modelli di riferimento, la moda, il linguaggio, gli stili di vita di un’immagine di Paese tanto più sconfortante quanto più si sale nella scala sociale. Scrittori di successo, grandi firme del giornalismo, leader politici, guitti, giocatori di calcio, manager e imprenditori si mescolano all’interno di una nuova torpida formazione sociale al vertice di quella scala che infetta tutta la nazione. So bene che in molti campi ci sono italiani che continuano a dare al mondo il contributo della loro intelligenza e del loro genio creativo ma proprio loro sono la migliore conferma della gravità dell’infezione perché nessuno di loro è espressione del nostro Paese: o sono cresciuti all’estero dove hanno trovato l’opportunità per farsi valere o sono scappati dall’Italia in cerca di aria fresca e quelli che vi rimangono sono corpi estranei, scontenti e delusi; in ogni caso non hanno niente a che fare con quella formazione sociale e col gruppo di potere che ha condannato l’Italia alla subalternità e l’ha ridotta al proprio livello di miseria morale culturale e intellettiva.
 Ormai ci sono due Italie: quella reale, un’italietta corrotta, asservita, ai margini dell’Europa e a rischio di estinzione e quella ideale scolpita attraverso i secoli e alimentata dalla voce sempre più flebile di scrittori e poeti, da Orazio a Rutilio, da Petrarca a Machiavelli a Vico fino a Leopardi, Carducci e al sublime Gabriele. Perfino Dante, nel suo municipalismo, ne avverte la grandezza, grande, nella sua invettiva, anche nella dissolutezza. È l’Italia del pensare in grande, del progettare in grande di politici, scienziati, artisti che hanno lasciato il segno nella bellezza, nella grandiosità monumentale, nel trionfo della razionalità. I nostri manuali presentano un quadro dell’evoluzione storica dell’Europa e della gerarchia delle nazioni europee completamente distorto dalla prospettiva monarcocentrica propria dell’histoire bataille alla quale sfugge il vero soggetto della storia, la cultura.
Ormai ci sono due Italie: quella reale, un’italietta corrotta, asservita, ai margini dell’Europa e a rischio di estinzione e quella ideale scolpita attraverso i secoli e alimentata dalla voce sempre più flebile di scrittori e poeti, da Orazio a Rutilio, da Petrarca a Machiavelli a Vico fino a Leopardi, Carducci e al sublime Gabriele. Perfino Dante, nel suo municipalismo, ne avverte la grandezza, grande, nella sua invettiva, anche nella dissolutezza. È l’Italia del pensare in grande, del progettare in grande di politici, scienziati, artisti che hanno lasciato il segno nella bellezza, nella grandiosità monumentale, nel trionfo della razionalità. I nostri manuali presentano un quadro dell’evoluzione storica dell’Europa e della gerarchia delle nazioni europee completamente distorto dalla prospettiva monarcocentrica propria dell’histoire bataille alla quale sfugge il vero soggetto della storia, la cultura.

Camillo Benso conte di Cavour
In questa prospettiva nell’Europa uscita dal medio evo gli stati nazionali avrebbero schiacciato l’Italia politicamente frammentata e ininfluente. Niente di più falso: nel periodo di massima potenza della Francia del Re Sole (parafraso un celebre storico) al canto dei te deum per le vittorie militari nelle città e nelle campagne si moriva di fame e il buio dell’ignoranza copriva tutto il Paese mentre l’Italia, dal nord al sud, era il giardino d’Europa, il faro di una rinnovata civiltà. E se spagnoli, francesi e tedeschi si contendevano il Belpaese era perché ne avvertivano – come nuovi barbari – il fascino e la superiorità. La coscienza di questa grandezza animava la politica estera di Cavour, che pure nella contingenza fattuale rappresentava uno staterello di dimensione regionale, si esprimeva nella superbia crispina, nello scalpitare del giovane Regno ansioso di scardinare gli equilibri europei e nel pretendere il riconoscimento di quella centralità che le spetta quasi per decreto divino e che senza soluzione si continua a pretendere nel ventennio mussoliniano. Durante il quale, non a caso, esplode una fioritura di intelligenze irripetibile e unica al mondo; che fossero o no in sintonia col regime, e molti non lo erano, rimanevano comunque espressione della cultura italiana.
Dopo la guerra tutto si affloscia. L’Italia ripudia se stessa, deride la grande nobile retorica risorgimentale, fruga nelle debolezze di Garibaldi, si impegna a immiserire il processo dell’unificazione nazionale, guarda al colonialismo italiano con gli occhi della Francia e dell’Inghilterra, imputa a se stessa le nefandezze della Germania nazista, nega l’evidenza di essere stata al vertice della diplomazia mondiale, sorvola sulle gigantesche opere pubbliche realizzate in un lasso tempo brevissimo ma incredibilmente dilatato rispetto ai reali limiti cronologici, come sempre accade nei momenti magici della storia.

PUBBLICITA’
Tutto scotomizzato, negato, rimosso, ridotto all’assassinio di Matteotti, alle leggi razziali, alla disfatta militare. Nessuno che dica: Matteotti fu vittima dello strascico di violenza che aveva preceduto e seguito la grande guerra, quando ancora scorrazzavano gruppi di facinorosi fuori controllo; nessuno che dica che Matteotti vivo contava meno di zero e avrebbe nuociuto al regime molto meno che da morto; nessuno che dica che negli anni Venti dello scorso secolo non c’è un solo Paese europeo che non abbia sofferto molto più dell’Italia della violenza politica. Poi le leggi razziali, conditio sine qua non per sfuggire all’accerchiamento e allearsi con la Germania, nella quale per altro provvedimenti legislativi analoghi avevano ben altre motivazioni ed erano destinati ad essere il funesto viatico per la farneticante “soluzione finale”. Se è vero che durante il regime al di là dell’apparentemente unanime consenso esisteva un’opposizione che agiva dall’interno e soprattutto all’estero e se è vero che le leggi razziali – firmate dal re – erano fasciste si potrebbe pensare che ci sia stata se non una sollevazione interna contro quelle leggi quantomeno una mobilitazione fuori dei confini da parte dei fuoriusciti comunisti, socialisti o liberali. Niente, niente di niente e viene in mente il detto: chi tace acconsente. Detto questo le leggi razziali cosa effettivamente comportavano? una cosa gravissima e imperdonabile: la limitazione dei diritti di cittadinanza, con esclusione dall’insegnamento, dai pubblici uffici e dall’esercito (per altro con molte eccezioni) per i cittadini di religione – mi rifiuto di scrivere razza – ebraica. A parte l’ombra di Hitler chi appena appena ha letto qualche libro e conosce un po’ di storia sente puzza di Vaticano più che di fascismo, anche perché sa di tanti ebrei fascisti della prima ora. E siamo lontani anni luce dalle deportazioni, dall’esilio forzato, dai campi di concentramento, dagli espropri. Così come l’opinione pubblica dell’Italia fascista era lontana dall’antisemitismo di casa in Francia, in Spagna, in Inghilterra – dove anche i cattolici sono stati a lungo discriminati emarginati e perseguitati – e profondamente radicato in Austria, in Germania per non dire della Polonia e degli altri paesi dell’est teatro di periodici assalti ai ghetti.
E, leggi razziali o no, chi ricorda che nella Francia di Vichy più o meno forzosamente alleata con la Germania gli ebrei cercavano riparo nella parte occupata e amministrata dall’Italia? Ma la versione ufficiale che si è imposta negli ultimi decenni vuole l’assimilazione di fascismo e nazismo fino al limite grottesco di imputare agli italiani una corresponsabilità nell’olocausto: agli italiani, non a polacchi, cechi o, con particolare zelo e diretta partecipazione, ucraini. E infine la disfatta. Si dimentica che se l’Italia avesse investito in armamenti e nelle forze armate le risorse e la capacità organizzativa (quella che oggi da noi è completamente assente) che portò alla riqualificazione delle aree rurali e alla fondazione di città – da Littoria a Carbonia, da Guidonia a Pontinia da Aprilia a Tirrenia, senza dire del rifacimento di Rimini o del nuovo centro di Livorno (e sono solo le prime cose in ambito urbanistico che mi vengono in mente), alla bonifica di terre malsane, al rimboschimento dell’Appennino, all’istruzione di massa, alla creazione di strutture sociali come la città dei ragazzi del Calambrone, le sorti della guerra sarebbero state diverse tanto più che la ricerca e la tecnologia italiane erano all’avanguardia. Gli storici di domani, soprattutto se verranno fuori documenti che ci si è affrettati ad occultare e distruggere, diranno chi ha voluto la guerra e chi ha convinto Mussolini a un intervento a lungo procrastinato. Io mi limito alla constatazione valida per tutte le guerre che la colpa è di tutti e di nessuno e che la guerra è sempre, sempre, un evento esecrabile, barbarico, contro la civiltà e l’umanità, imputabile alla stupidità dei governanti e alla supina acquiescenza dei popoli. Non riesco a vedere particolari meriti in chi la vince o speciali colpe in chi ne esce sconfitto; di sicuro qualcuno ci guadagna ma i ragazzi mandati a combattere e i civili sotto le bombe ci rimettono sempre. E, lo ripeto, sono convinto che la grandezza di una nazione non si misura con parametri militari ma con il livello di istruzione, il potere culturale, il grado di civiltà giuridica e di giustizia sociale e col peso del proprio patrimonio storico artistico e letterario.
 Per concludere: dovunque volgo lo sguardo vedo un deserto di valori, di intelligenza, di cultura e non mi riferisco solo ai governanti e ai figuri che si muovono nel sottobosco della politica. Sono proprio gli italiani, le persone comuni e in particolare i giovani che sembrano estranei alla loro terra, intrusi in una civiltà che non è loro, come croati e sloveni installatisi nelle case veneziane, ignari o indifferenti rispetto alla propria storia e privi di identità. Il patriottismo prima che al sentimento rinvia alla consapevolezza storica e culturale e al senso di appartenenza e di continuità; è stato stupidamente confuso con la retorica del regime fascista dimenticando che quel regime aveva semplicemente raccolto il testimone del risorgimento e della nuova Italia celebrata da Carducci, Pascoli, D’Annunzio e in quel capolavoro assoluto di letteratura pedagogica che è Cuore di De Amicis. Fascismo anche questo? retorica stucchevole? Si può anche pensarla così, per carità; ma allora non ci si venga a chiedere di solidarizzare con l’Ucraina perché le viene strappato un pezzo di territorio non suo, non ci si propongano le patrie degli altri, si faccia finita col conto delle medaglie alle Olimpiadi e non si pretenda che ci si inorgoglisca per una ragazzotta sugli sci o in piscina che arriva al traguardo prima degli altri o per undici tamarri tatuati con la maglia azzurra che corrono dietro a un pallone; e consumiamo la nostra esistenza nel privato con l’illusione di essere cittadini del mondo quando, al contrario, si è sospinti ai margini del mondo, non più attori ma spettatori – e vittime – di quel che accade sulla scena. Se però si guarda con l’occhio rivolto non alla miseria dell’essere ma alla dignità del dover-essere, non all’Italia che ci si presenta davanti ma all’Italia ideale protagonista della storia della civiltà e se vogliamo che la prima torni a coincidere con la seconda cominciamo a riprendere il filo della nostra storia con la capacità di vederne la grandezza anche negli errori, anche in ciò che rapportato al presente ci appare intollerabile. È un invito che rivolgo innanzitutto a me stesso: non lasciamo che la Meloni al governo, il festival di Sanremo, le esternazioni di Caprarica, gli editoriali o i titoli dei giornali (fantastico il Tempo sulla missione della Meloni a Kiev per mettere le mani dei suoi sul business della ricostruzione: “Premier di pace”) e il torpore di una pubblica opinione che mugugna rassegnata ed è incapace di mobilitarsi senza il pifferaio di turno ci facciano dimenticare il privilegio di essere italiani.
Per concludere: dovunque volgo lo sguardo vedo un deserto di valori, di intelligenza, di cultura e non mi riferisco solo ai governanti e ai figuri che si muovono nel sottobosco della politica. Sono proprio gli italiani, le persone comuni e in particolare i giovani che sembrano estranei alla loro terra, intrusi in una civiltà che non è loro, come croati e sloveni installatisi nelle case veneziane, ignari o indifferenti rispetto alla propria storia e privi di identità. Il patriottismo prima che al sentimento rinvia alla consapevolezza storica e culturale e al senso di appartenenza e di continuità; è stato stupidamente confuso con la retorica del regime fascista dimenticando che quel regime aveva semplicemente raccolto il testimone del risorgimento e della nuova Italia celebrata da Carducci, Pascoli, D’Annunzio e in quel capolavoro assoluto di letteratura pedagogica che è Cuore di De Amicis. Fascismo anche questo? retorica stucchevole? Si può anche pensarla così, per carità; ma allora non ci si venga a chiedere di solidarizzare con l’Ucraina perché le viene strappato un pezzo di territorio non suo, non ci si propongano le patrie degli altri, si faccia finita col conto delle medaglie alle Olimpiadi e non si pretenda che ci si inorgoglisca per una ragazzotta sugli sci o in piscina che arriva al traguardo prima degli altri o per undici tamarri tatuati con la maglia azzurra che corrono dietro a un pallone; e consumiamo la nostra esistenza nel privato con l’illusione di essere cittadini del mondo quando, al contrario, si è sospinti ai margini del mondo, non più attori ma spettatori – e vittime – di quel che accade sulla scena. Se però si guarda con l’occhio rivolto non alla miseria dell’essere ma alla dignità del dover-essere, non all’Italia che ci si presenta davanti ma all’Italia ideale protagonista della storia della civiltà e se vogliamo che la prima torni a coincidere con la seconda cominciamo a riprendere il filo della nostra storia con la capacità di vederne la grandezza anche negli errori, anche in ciò che rapportato al presente ci appare intollerabile. È un invito che rivolgo innanzitutto a me stesso: non lasciamo che la Meloni al governo, il festival di Sanremo, le esternazioni di Caprarica, gli editoriali o i titoli dei giornali (fantastico il Tempo sulla missione della Meloni a Kiev per mettere le mani dei suoi sul business della ricostruzione: “Premier di pace”) e il torpore di una pubblica opinione che mugugna rassegnata ed è incapace di mobilitarsi senza il pifferaio di turno ci facciano dimenticare il privilegio di essere italiani.
post scriptum
Pare che molto opportunamente il ministro Valditara abbia disposto un’ispezione o un provvedimento disciplinare contro la preside fiorentina che col pretesto di una rissa fra ragazzi si è avventurata in un’analisi sull’origine del fascismo e sul pericolo di un suo ritorno. Mi risulta che altri presidi e Collegi di insegnanti le abbiano fatto coro e siano saltati addosso al ministro. Ho letto il documento della dirigente scolastica: sciocchezze, banalità, luoghi comuni, falsità – una perla: la democrazia sarebbe nata dalla resistenza – che danno la misura del livello miserevole della nostra scuola. È in questi ambienti che si formano i nostri giovani: frasi fatte, sentito dire, assenza di letture, di studio, non dico di pensiero critico ma di semplice informazione.

FRA SCEPSI E MATHESIS Il libro di Pierfranco Lisorini acquistalo su… AMAZON