La lingua va tutelata ma guai affidarne la tutela alle persone sbagliate
 Luigi Russo era un omone irascibile capace di inseguire tutt’intorno la sapienza pisana lo studente che, con l’esame che si metteva male, aveva arraffato il libretto e se l’era data a gambe per evitare la macchia del “respinto”. Ed era anche uno che andava su tutte le furie se durante la correzione di un elaborato si imbatteva in un “nella misura in cui”, il francesismo adorato dagli antesignani della “messa a terra” (con buona pace degli elettricisti). Altri tempi, altre generazioni, altri intellettuali e altro senso della lingua e dell’italianità. Come Bruno Widmar, del quale ricordo la stizzita risposta ad un tale che durante una conferenza gli aveva chiesto che cosa fosse funzionale ad una corretta analisi epistemologica: “Cosa intende con funzionale?”, aveva risposto, “se intende dire utile dica utile perbacco, che non è una parolaccia!”. Nell’inarrestabile piano inclinato della volgarità – e speriamo che con l’era meloniana si sia toccato il fondo -, radical chic che sorseggiano la tazzina di caffè col mignolo alzato, maestrine prestate alla politica attente a non farsi sfuggire l’ultima novità, i villani rifatti al vertice della nostra imprenditoria e gli analfabeti che riempiono le redazioni, i palcoscenici, i campi di calcio e, ahimè, le cattedre universitarie ci stanno subissando di inutili neologismi, di metafore stucchevoli, di una serie infinita di “quant’altro” e di “piuttosto che” con valore disgiuntivo e non avversativo, per non dire dell’ “occhio del ciclone”, del quale si rovescia puntualmente il significato e dell’ineffabile “possibilità di poter”, che fa il paio con la “necessità di dover,”senza trascurare il “così epocale” del Capo sello Stato, per il quale ci sono eventi più epocali, meno epocali e, appunto, enormemente epocali.
Luigi Russo era un omone irascibile capace di inseguire tutt’intorno la sapienza pisana lo studente che, con l’esame che si metteva male, aveva arraffato il libretto e se l’era data a gambe per evitare la macchia del “respinto”. Ed era anche uno che andava su tutte le furie se durante la correzione di un elaborato si imbatteva in un “nella misura in cui”, il francesismo adorato dagli antesignani della “messa a terra” (con buona pace degli elettricisti). Altri tempi, altre generazioni, altri intellettuali e altro senso della lingua e dell’italianità. Come Bruno Widmar, del quale ricordo la stizzita risposta ad un tale che durante una conferenza gli aveva chiesto che cosa fosse funzionale ad una corretta analisi epistemologica: “Cosa intende con funzionale?”, aveva risposto, “se intende dire utile dica utile perbacco, che non è una parolaccia!”. Nell’inarrestabile piano inclinato della volgarità – e speriamo che con l’era meloniana si sia toccato il fondo -, radical chic che sorseggiano la tazzina di caffè col mignolo alzato, maestrine prestate alla politica attente a non farsi sfuggire l’ultima novità, i villani rifatti al vertice della nostra imprenditoria e gli analfabeti che riempiono le redazioni, i palcoscenici, i campi di calcio e, ahimè, le cattedre universitarie ci stanno subissando di inutili neologismi, di metafore stucchevoli, di una serie infinita di “quant’altro” e di “piuttosto che” con valore disgiuntivo e non avversativo, per non dire dell’ “occhio del ciclone”, del quale si rovescia puntualmente il significato e dell’ineffabile “possibilità di poter”, che fa il paio con la “necessità di dover,”senza trascurare il “così epocale” del Capo sello Stato, per il quale ci sono eventi più epocali, meno epocali e, appunto, enormemente epocali.
 E non mi soffermo sulla pronuncia, con i bòschi che diventano bóschi e la néve nève. Non ce la prendiamo allora se l’Europa anglofona ci ha imposto una resilienza che ha fatto pensare ai compagni toscani ad un refuso o a una variante lessicale per resistenza e ad un richiamo all’antifascismo, che va sempre bene. Il traslato appartiene all’inglese che ha mutuato il termine dal francese, dove si è psicologizzato, ma il termine è ottima lingua, ed è nostro, se rimane nel suo ambito, che è quello della tecnologia. Fuori di essa in italiano è presente solo nel participio resiliente, voce rara e letteraria attestata anche in Levi. Poi i compagni, dopo averlo con un po’ di fatica metabolizzato, se ne sono invaghiti, o meglio ne sono rimasti “intrigati”, e hanno cominciato a usarlo come condimento in tutte le loro vacue elucubrazioni. Intanto le maestrine del Pd dopo essersi a lungo esercitate con la cassetta degli attrezzi hanno finito per abbandonarla anche perché la loro era desolatamente vuota.
E non mi soffermo sulla pronuncia, con i bòschi che diventano bóschi e la néve nève. Non ce la prendiamo allora se l’Europa anglofona ci ha imposto una resilienza che ha fatto pensare ai compagni toscani ad un refuso o a una variante lessicale per resistenza e ad un richiamo all’antifascismo, che va sempre bene. Il traslato appartiene all’inglese che ha mutuato il termine dal francese, dove si è psicologizzato, ma il termine è ottima lingua, ed è nostro, se rimane nel suo ambito, che è quello della tecnologia. Fuori di essa in italiano è presente solo nel participio resiliente, voce rara e letteraria attestata anche in Levi. Poi i compagni, dopo averlo con un po’ di fatica metabolizzato, se ne sono invaghiti, o meglio ne sono rimasti “intrigati”, e hanno cominciato a usarlo come condimento in tutte le loro vacue elucubrazioni. Intanto le maestrine del Pd dopo essersi a lungo esercitate con la cassetta degli attrezzi hanno finito per abbandonarla anche perché la loro era desolatamente vuota.
 Ma il linguaggio non è involgarito dai neologismi inutili o dalle metafore discutibili: questi e quelli possono essere il segno di un pensiero forte e originale se scaturiscono dall’interno di un ragionamento autonomo: diventano ridicoli quando vengono pedissequamente ripetuti e rimbalzano di bocca in bocca come un mantra, un segno di distinzione e di reciproco riconoscimento, suggello del nichilismo culturale e intellettivo di questi sciagurati tempi. Perché alla lingua non si chiede solo chiarezza e sobrietà ma anche e soprattutto il rispetto di un principium individuationis, vale a dire la sua declinazione personale nell’ambito della comunicabilità. C’è, al contrario, un’irresistibile corsa all’uniformazione, una sorta di tendenza all’appiattimento, alla robotizzazione del linguaggio come se l’individuo nel comunicare dovesse perdere la sua individualità invece di esprimerla e in qualche modo imporla.
Ma il linguaggio non è involgarito dai neologismi inutili o dalle metafore discutibili: questi e quelli possono essere il segno di un pensiero forte e originale se scaturiscono dall’interno di un ragionamento autonomo: diventano ridicoli quando vengono pedissequamente ripetuti e rimbalzano di bocca in bocca come un mantra, un segno di distinzione e di reciproco riconoscimento, suggello del nichilismo culturale e intellettivo di questi sciagurati tempi. Perché alla lingua non si chiede solo chiarezza e sobrietà ma anche e soprattutto il rispetto di un principium individuationis, vale a dire la sua declinazione personale nell’ambito della comunicabilità. C’è, al contrario, un’irresistibile corsa all’uniformazione, una sorta di tendenza all’appiattimento, alla robotizzazione del linguaggio come se l’individuo nel comunicare dovesse perdere la sua individualità invece di esprimerla e in qualche modo imporla.
Poi l’inglese, nella sua versione americana. Lo dico forte e chiaro: per la formazione culturale e spirituale della persona c’è alcuna necessità di imparare le lingue, tantomeno l’inglese. Queste possono servire per chi deve lavorare in contesti internazionali o immagina per sé un futuro di cameriere all’estero ma sono del tutto inutili per il 99% della popolazione, quali che siano il ruolo o lo status.

PUBBLICITA’
C’è invece la necessità di padroneggiare la propria lingua, di saper passare da un registro all’altro, di dare spazio alla propria ideazione: le parole non sostituiscono i concetti ma i concetti senza parole sono muti. E come c’è un decoro e c’è un tratto personale nell’abbigliamento così c’è un decoro e c’è un tratto personale nella comunicazione, che la nostra scuola e la nostra società non sono evidentemente più in grado di garantire.
La lingua si nutre del proprio passato e produce da sé il proprio futuro: è un corpo vivo che cresce correttamente se non viene distorto da forze esterne o non viene privato della propria linfa. Ha soprattutto bisogno di parlanti che la mantengano in vita: il latino parlato scomparve quando venne meno la minoranza colta che aveva in mano lo Stato, quando le istituzioni scolastiche crollarono e l’esercito si imbarbarì. Rinacque con una nuova veste con l’affermarsi di una nuova borghesia cittadina, di una organizzazione politico amministrativa municipale, col ritrovato amore per la vita, con un rinnovato senso di appartenenza e col bisogno di comunicare oltre i limiti dei bisogni primari.
In tutti i Paesi del mondo la difesa dell’identità nazionale, quindi anche della lingua, è un impegno di tutte le forze politiche. Ci mancherebbe che così non fosse, potrà dire qualcuno. Purtroppo in Italia non è così, non è mai stato così: che si chiamassero anarchici, socialisti, comunisti o come ora piddini, io li chiamerò genericamente compagni, non sono mai stati semplicemente internazionalisti, ostili ai confini, cittadini del mondo ma dichiaratamente nemici della nazione, infastiditi dal concetto di Patria e, per converso, innamorati delle patrie altrui, fossero ieri la Francia o la Russia o, come accade oggi, l’America o l’Ucraina. Il risultato è che da noi, e solo da noi, l’identità nazionale, la Patria, la difesa della lingua sono considerati parte del bagaglio politico e culturale della destra e, per i più zelanti, della destra “fascista”. È una cosa abominevole ma dobbiamo farcene una ragione: è così. E, di conseguenza e per una parvenza di coerenza, questo governo, che della destra è una grottesca caricatura, per bocca dei Fratelli d’Italia. ha timidamente posto il tema della lingua e dell’invasione degli anglismi. L’ha fatto alla sua maniera, rumorosamente ma senza convinzione, senza un piano e soprattutto senza le carte in regola. Perché se vero, com’è vero, che non c’è un argine alla penetrazione dell’inglese come se l’italiano fosse non dico il lettone o il sami ma il kirundi, che, con tutto il rispetto non sono in grado di dar voce alla cultura contemporanea, è anche vero che prima di difenderla da attacchi esterni la lingua va difesa dall’interno e non sarà certo in grado di farlo il ceto politico trainato e rappresentato dalla Meloni.

Fabio Rampelli
Quel ceto politico che con un po’ di ritardo si è accorto che il Recovery Fund diventa in Francia Plan de relance e in Spagna Plan de recuperación e che, perché sotto sotto, si considera erede di tempi in cui chauffeur diventò da un giorno all’altro l’autista e Mickey mouse Topolino, pieno di vergogna è corso ai ripari con una delle sue rodomontate. E così, a prima firma Fabio Rampelli, ha presentato una proposta di legge, che come al solito non andrà mai in porto, con la quale l’uso della lingua italiana è reso obbligatorio per la fruizione di beni e servizi (ma lo era già), ogni comunicazione pubblica deve essere redatta in italiano (e ci mancherebbe che così non fosse) ed è vietato usare sigle o denominazioni straniere per ruoli aziendali, a meno che non siano intraducibili e per chi sgarra multe da 5 a 100.000 euro (boom!). E nelle scuole stop ai corsi in lingua straniera, quando la televisione di Stato trasmette allegramente il telegiornale in lingua ucraina. Che nella pubblica amministrazione – e, aggiungo, nella stampa e nelle televisioni – debbano essere evitati termini inglesi assolutamente inutili come briefing, webinar, meeting o step by step è pacifico ma che questo possa accadere per iniziativa di un governicchio quale l’attuale e con politici di questo calibro è una pia illusione.

Il Ministro Lollobrigida
Qualunque causa, anche la più nobile, nelle mani di un cattivo difensore perde smalto e credibilità: cosa ci si può aspettare da gente che un giorno spara l’idiozia che l’Italia ha bisogno di mezzo milione di stranieri e il giorno dopo agita lo spauracchio della sostituzione etnica? da gente che dopo aver riconosciuto l’ovvietà che la strage di va Rasella è una macchia e non un vanto per la resistenza si affretta a fare marcia indietro mostrando così di basare le proprie convinzioni su slogan e sentito dire e non sulla conoscenza dei fatti, da gente che non ha il coraggio di dire apertamente che l’unico responsabile del naufragio di Cutro è il demente che voleva sbarcare su una spiaggia per evitare il porto dove necessariamente lui e i suoi compari sarebbero stati identificati (e sarebbe meglio che invece di sguazzare nel piagnisteo e nella retorica si indagasse sul marcio che c’è dietro questa invasione eterodiretta senza alzare polveroni tirando in ballo prima il gruppo Wagner e la Russia e ora la crisi in Tunisia).
Post scriptum
Mi si perdoni se vado fuori tema. Secondo Gramellini se Fontana, il leghista presidente della Camera, presenziando alla commemorazione di Bachelet presso il liceo a lui intitolato lo chiama come si scrive e non con la pronuncia francese significa che ne ignorava l’esistenza e non conosceva le circostanze della sua morte, che non sa niente delle brigate rosse e degli anni di piombo, è digiuno di storia ed è un pessimo esempio per gli studenti. Sospetto che nella sua tazzina non ci sia solo caffè.
FRA SCEPSI E MATHESIS Il libro di Pierfranco Lisorini acquistalo su… AMAZON

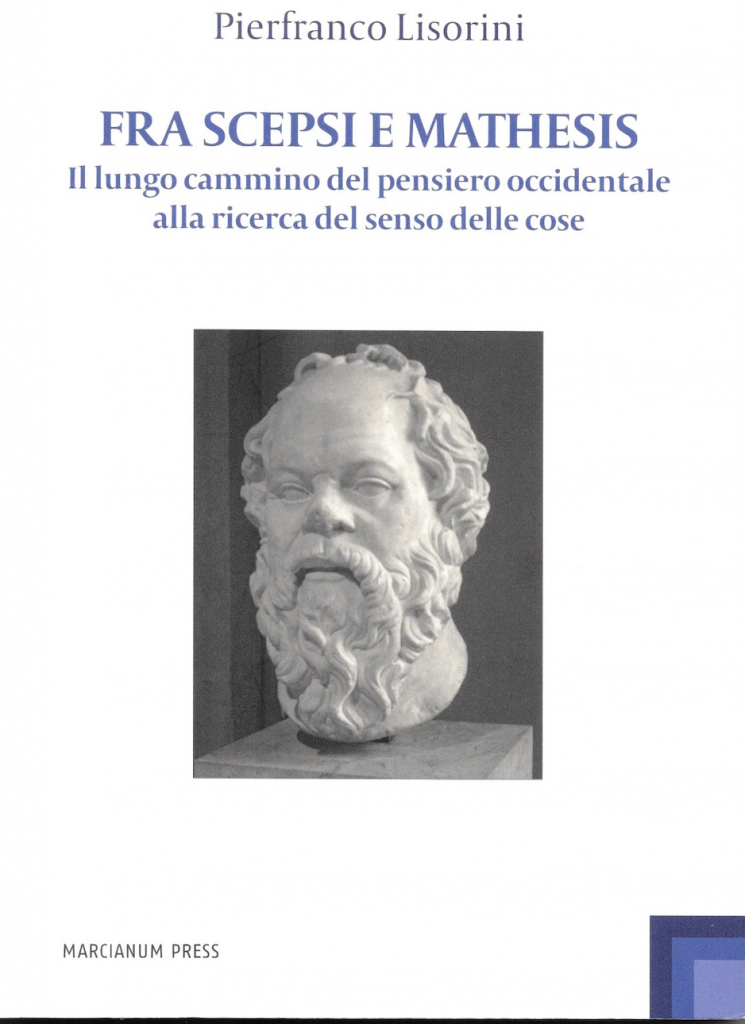
“…resiliente, voce rara e letteraria presente anche in Levi”. Giusto; se non che i Levi della letteratura italiana sono due: Carlo e Primo (o anche tre se vogliamo aggiungere Arrigo Levi); ragione per cui è buona norma per gli addetti ai lavori, quando citano uno dei tre, aggiungere il prenome che, in questo caso, è Primo. Ci voleva tanto? Mah, misteri dell’animo umano!