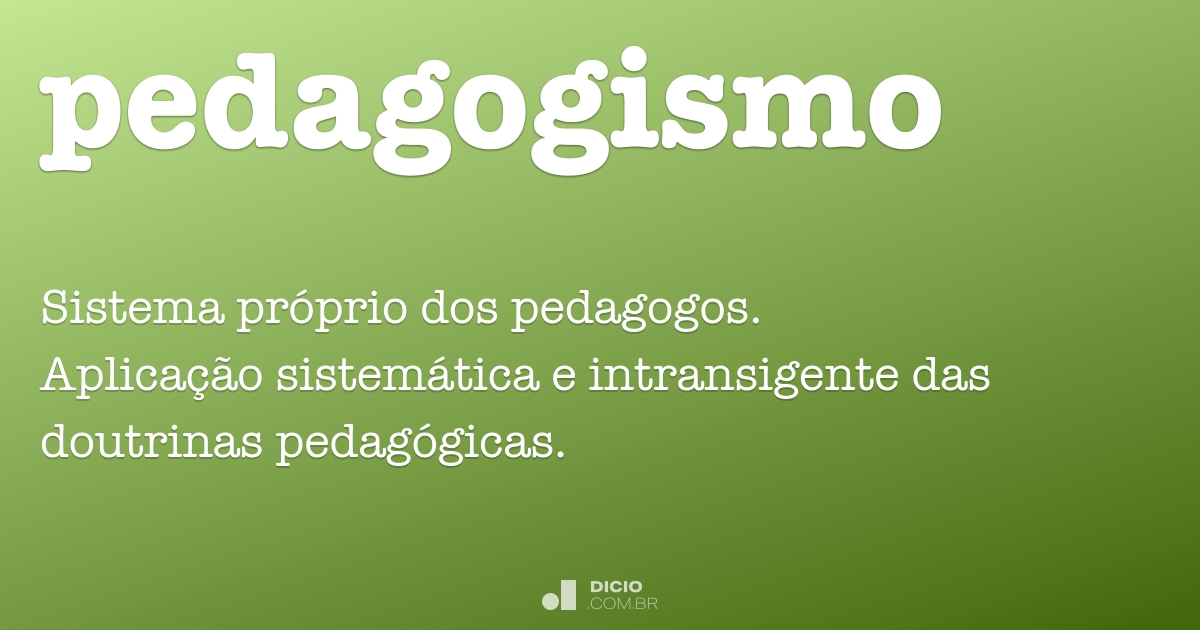Il pedagogismo malattia mortale della scuola italiana
|
Il pedagogismo malattia mortale
della scuola italiana
La scuola italiana è una grande ammalata. Lo è da molti anni |
Il pedagogismo malattia mortale della scuola italiana
La scuola italiana è una grande ammalata. Lo è da molti anni: i primi segni della malattia coincidono col mitico Sessantotto e da allora i tentativi di risanarla ne hanno puntualmente aggravato le condizioni tanto da ridurla nello stato comatoso in cui oggi si trova. Intendiamoci: nel nostro Paese dare addosso alla scuola e agli insegnanti è sempre stato uno sport largamente praticato sia per l’invidia sociale di quanti se ne sentivano esclusi o marginalizzati sia per le frustrazioni patite dai rampolli della borghesia a causa degli ostacoli che essa poneva lungo la strada che per nascita era loro spianata. Del resto sono molto di più quelli che a scuola hanno subito qualche ferita narcisistica e hanno dovuto sgonfiare il proprio ego di coloro ai quali il percorso scolastico ha infuso sicurezza e regalato gratificazioni e conferme. E c’è per tutti, anche quando prevale la nostalgia, l’imbarazzo di una sudditanza che, freudianamente, risveglia il sentimento di inferiorità del bambino che si confronta con l’adulto. Un imbarazzo che porta ad esiti assai diversi, dalla rimozione allo spostamento alla formazione reattiva all’identificazione e che spesso è responsabile della scelta professionale. La scuola, insomma, per usare l’approccio di Osgood, mantiene in ognuno di noi una fortissima connotazione, non è un concetto neutro e la sua presenza comporta sempre un certo disagio. Consapevole di questo, non mi interessa tanto l’atteggiamento diffuso o prevalente verso la scuola riconducibile a motivazioni psicologiche o psicosociali e vorrei sgombrare il campo anche dai luoghi comuni, i giudizi preconfezionati, le affermazioni orecchiate che scattano come riflessi condizionati. La malattia della scuola è reale, non si risolve in quegli stereotipi, è reale e documentata dalle statistiche ufficiali ricavate dagli enti che la monitorizzano e ne attestano il continuo arretramento nei confronti di tutti i Paesi, non solo di quelli europei. Ed è una malattia che infetta la società e si manifesta non solo nell’ignoranza diffusa fra i giovani, nella deriva della lingua italiana, nella scarsa attrattiva che hanno musei e città d’arte, che sembrano destinati ai soli turisti stranieri, ma nello stupore che desta un giornalista televisivo o della carta stampata capace di costruire un periodo complesso senza strafalcioni o in grado di disporre di adeguate coordinate spazio temporali per non ricadere nell’ormai storico kèssibol in cui la sprovveduta giornalista rai aveva trasformato la sicilianissima Cassibile, dove il 3 ottobre del 1943 si consumò il tradimento. Non si può che essere d’accordo con Luca Ridolfi quando sostiene che non si tratta di lacune ma di guasti strutturali imputabili ad un sistema formativo che non funziona più. L’ignoranza diffusa abbatte le barriere di classe, colpisce equamente ricchi e poveri, non risparmia laureati e ceti professionali e si accanisce soprattutto sui politici. I vecchi politici forse erano ladri ma almeno erano alfabetizzati; questi sempre ladri sono ma analfabeti come il nostro capo del governo che per fare il colto confonde l’albatros con l’airone, che tanto sempre uccelli sono e cominciano con la “a”, e si avventura in citazioni a sproposito di un Dante conosciuto attraverso Benigni. Ridolfi non è solo; sono ormai tanti gli “intellettuali” pentiti che invocano il ritorno al riassunto e, perché no, alla calligrafia ma la loro voce ora non ha più amplificatori perché quelle metodologie saranno pure utili ed efficaci ma sono politicamente neutre e non costano nulla. Questo però è un problema: non c’è business.
Da che pulpito vengono le prediche Leggo su due siti afferenti all’area progressista due diverse ma convergenti diagnosi sui mali della scuola; in uno si rimarca come «la pessima riforma della scuola, trionfalmente varata da Renzi dopo anni di retorica sulla meritocrazia e contro ‘il falso egualitarismo della sinistra’, porta a termine un processo di smantellamento dell’istruzione pubblica iniziato negli anni ’80 e promosso in egual misura dal centro destra e dal centro sinistra». Nell’altro si dichiara che «nelle scuole italiane servono più insegnanti uomini come sostiene Barbara Mapelli, docente di pedagogia delle differenze all’Università Bicocca di Milano. E non è l’unica: da oltre una decina di anni si susseguono analisi e studi che puntano il dito contro l’eccessiva femminilizzazione della scuola italiana. Un fenomeno cominciato negli anniSessanta, che non sembra arrestarsi». Siamo al punto che le critiche più aspre alla politica scolastica e le lamentazioni sulle condizioni della scuola vengono proprio da chi ha condiviso quella politica e ha contribuito a creare quelle condizioni e che ora mentre riflette sul male suggerisce rimedi che sono in realtà dei veleni. Non c’è infatti il minimo segno di reminiscenza, non c’è nessuno che dica: «Abbiamo sbagliato tutto, siamo stati vittime delle nostre illusioni». Accade così che un’analisi spassionata e rigorosa venga compromessa proprio da quelli che la condividono, dagli occasionali compagni di viaggio che continuano a spingerti verso la direzione sbagliata. Che è poi quella dei loro padri e dei loro nonni che con le loro stesse parole d’ordine, col loro stesso anelito per “le magnifiche sorti e progressive” e la loro smania di rinnovamento hanno rovinato la scuola e non solo quella. Come quel Bruno Ciari, l’artefice di quel portento pedagogico che sono le scuole dell’infanzia bolognesi e reggiane, che pretendeva di fare dell’educazione statale infantile «un modello sociale e culturale in alternativa critica e costruttiva dinanzi al modello familiare», quel Bruno Ciari che definiva il doposcuola “discriminante ed emarginante” di fronte al salvifico tempo pieno, fatto passare per lo spartiacque fra scuola borghese e classista e scuola di tutti per la quale occorre procedere ad «un rinnovamento della preparazione politico-pedagogica e culturale degli insegnanti». Sappiamo com’è andata. Un pedagogismo d’accatto, una mare di retorica che ha sommerso ogni residuo di professionalità, insegnanti smarriti e impreparati o indottrinati, e ugualmente impreparati, generazioni che non sanno scrivere, leggono con difficoltà, sono terrorizzate dal calcolo. Sappiamo com’è andata. La scuola è diventata un parcheggio per i figli, costretti a rimanere otto ore in ambienti chiusi, spesso fatiscenti, con quella grande conquista pedagogica che è il momento della mensa, strombazzato dalle garrule sostenitrici del nuovo negli anni Settanta come la realizzazione di un’agape che arricchisce tutti, insegnanti, alunni, inservienti e che, di sicuro è un discreto affare per le cooperative che la gestiscono e un peso intollerabile per le famiglie, quelle, s’intende, che sono costrette a pagarla anche per quelli che non pagano. Almeno il doposcuola era un modo per alleviare lo svantaggio di bambini privi di un efficace sostegno familiare, che a casa loro non avevano né lo spazio fisico né quello ambientale e psicologico per studiare e fare i compiti. Già, i compiti a casa, un obiettivo ricorrente dei critici della scuola di cui è bene diffidare. Non più tardi di una settimana fa il ministro (non ministra) Giannini, mi verrebbe da dire il peggio pezzo del governo Renzi se me ne venisse in mente uno migliore, irrompe nella didattica unendosi al coro dei genitori ostili ai compiti a casa garantendo che «con la Buona Scuola sta partendo un cambiamento culturale nella scuola con modalità innovative e interattive di lavoro in classe e fuori dalla classe. Il carico di compiti va ovviamente dosato a seconda dell’età degli alunni ma proprio con le nuove modalità previste dalla 107 sia i ragazzi che i docenti saranno maggiormente responsabilizzati». Secondo la migliore tradizione della sinistra la signora ministro non dice ma allude, fa intendere, lancia segnali e ammiccamenti. E ancora una volta il cambiamento, il tarlo che corrode un edificio che per natura e funzione è conservativo. Tanti anni fa, prima del fatidico Sessantotto, c’era stata l’infatuazione per il lavoro di gruppo ma allora la scuola produceva ancora gli anticorpi per impedire la diffusione del virus e ne era uscita indenne. Più tardi era rimbalzata anche da noi la moda americana delle macchine per insegnare, un retaggio skinneriano che almeno aveva dalla sua un buon corredo di verifiche sperimentali; poi sono venute le mappe concettuali, che tuttora imperversano. Le scuole psicologiche, dal comportamentismo al cognitivismo all’approccio sistemico sono state fonti di preziosi suggerimenti ma anche di trasposizioni ingenue e superficiali. Alle quali, in modi spesso contraddittori, tendono a sovrapporsi le impalcature metadidattiche, le utopie sociali, i progetti educativi e l’escatologia rivoluzionaria.
Dagli alla lezione ex cathedra La cultura dominante ha da tempo accantonato la weltanschauung marxista per rifugiarsi nelle ideologie, che non sono altro che sistemi di pregiudizi più o meno organici, e quando sono state metabolizzate non c’è più verso di scalzarle. Molte di esse, purtroppo, investono la scuola. Ne è un buon esempio ancora il ministro Giannini che proclama: «la formazione dei docenti è quanto mai necessaria per favorire il successo formativo degli studenti, per i quali l’apprendimento non può più passare attraverso i metodi tradizionali, in primis quello della lezione frontale. Questo perché i nostri alunni sono nativi digitali, che apprendono tramite le nuove tecnologie, primi fra tutti computer e smartphone. Per la ragione suddetta, gli insegnanti dovranno andare a lezione di nuovi metodi e dovranno partecipare ai corsi di formazione organizzati dalle scuole al fine di approfondire tematiche fondamentali quali il digitale e la lingua inglese. L’inizio sarà un po’ faticoso e prevedo molti borbottii da parte dei docenti ma alla fine saranno contenti tutti. Si tratta di un progetto educativo per il quale ilgoverno ha investito 325 milioni di euro, un progetto che ci deve impegnare tutti a ripensare come si impara e come si insegna». La sparata del ministro mi ha riportato alla mente uno sgradevole ricordo romano dell’ormai lontano 1984 quando una specie di pachiderma messa a capo di una commissione esaminatrice sentenziava davanti all’attonito candidato che in un concorso-farsa per presidi aveva introdotto il tema della lezione: «la lezione frontale!? Ma che dice! Non esiste più, è roba del passato, ora la scuola è ben altro». Perché già allora i progressisti, e soprattutto le progressiste, recitavano il mantra della lezione partecipata, di qualcosa che non si sapeva bene cosa fosse ma che suonava bene, era comunque innovativo: via la cattedra, i banchi a semicerchio e oplà! il gioco è fatto. Sfugge loro che il rapporto maestro-discepolo è una faccenda che va oltre tutte le teorie pedagogiche, è connaturato con la nostra civiltà, ce n’è stato trasmesso il paradigma dall’antica Grecia e, tanto per volare un po’ più basso, che la capacità di ascoltare, di prestare attenzione, di intendere e rielaborare sono i fondamentali dell’educazione. Il brain storming può attendere. Eppure passano i decenni e quelle anime belle sono sempre lì, non si smuovono, cieche di fronte all’evidenza, sorde a qualunque richiamo alla realtà e al buon senso, intransigenti e inflessibili perché senza quelle due ideuzze che hanno in testa si perderebbero nel vuoto della loro ignoranza. E adesso hanno trovato la stampella di un modello didattico divulgato da un professore di chimica tedesco. La “classe rovesciata e il bello” dell’informatica (soprattutto per chi ci guadagna) Il ministro infatti non lo dice, e probabilmente non lo sa, ma questo rinnovato richiamo alla tecnologia rinvia alla più recente innovazione didattica, introdotta cautamente una decina di anni fa e oggi partita con nuovi argomenti all’attacco della lezione frontale, che in qualche modo si salda con la questione dei compiti a casa. Non entro nei dettagli di questa che mi auguro non diventi un’altra occasione per distrarre dai mali veri della scuola italiana e mi limito a darne una sommaria descrizione. L’impegno dello studente è sempre stato scandito da due tempi: la mattina all’interno dell’edificio scolastico, in classe, con l’insegnante che “spiega”. Il pomeriggio in casa a rielaborare i contenuti della spiegazione e a svolgere i compiti. L’idea è quella di rovesciare i tempi – da qui l’espressione “classe capovolta”, in inglese “flipped classroom” – spostando la lezione, in video, e ogni altro contenuto digitale e cartaceo al pomeriggio e riservando alla mattina la loro elaborazione. Gli editori, che già hanno sommerso la scuola con una valanga di carta inutile, hanno fiutato subito l’affare, attivando sinergie per la produzione di hardware e software. Tutto sulla testa di discenti, vellicati per la loro inclinazione al digitale e docenti, intimoriti dal rischio di essere accusati di misoneismo e di volersi sottrarre all’aggiornamento e al progresso. Un mondo alla rovescia. Qualunque sprovveduto sa che tablet e smartphone non hanno prodotto “nativi informatici”, per il motivo banale che chi spippola sui tasti è semplicemente l’utente finale che del mondo digitale si limita a cogliere i frutti. In secondo luogo la tecnologia, a cominciare da una modesta calcolatrice per finire coi programmi di scrittura, libera dalla fatica e fa guadagnare tempo ma non insegna né l’algoritmo né l’ortografia. La scuola, secondo il ministro, invece di correggere, compensare, moderare l’abuso di videogiochi, social network, facebook, ricondurre la tecnologia a semplice strumento dovrebbe adottarne il linguaggio, immergervisi completamente, spersonalizzarsi, fare piazza pulita del rapporto maestro-discepolo. Viene voglia di gridare: torniamo a Gentile! E, se Gentile non vi va bene, torniamo a Socrate, perbacco, e a tutta la nostra tradizione di civiltà pedagogica, la nostra paideia.
Un pò di chiarezza sui compiti a casa S’intende che gravare gli alunni di un carico eccessivo di compiti a casa non è solo un errore pedagogico ma è anche segno dell’incapacità della scuola di formare nei tempi e nei luoghi deputati per farlo. E questo vale per ogni ordine e livello di scuola, non solo per la scuola elementare. Il professore che delega allo studio domestico sul manuale quello che lui non è capace di trasmettere ha chiaramente sbagliato mestiere Ma va anche detto che i compiti a casa sono il nesso necessario che unisce momenti diversi di un unico processo di formazione e di crescita. La scuola non è un impiego, finito il quale si pensa ad altro, si è padroni del proprio tempo, si vive la propria vita. Don Milani, negli stessi anni in cui Ciari farneticava sull’educazione infantile, sosteneva che l’insegnante non doveva avere una vita privata, doveva essere totalmente, esclusivamente maestro. Una prospettiva terrificante, che trascurava la circostanza che una persona non si identifica mai col ruolo, a meno che non si voglia avallare la definizione aristotelica del dulos perì fuseos. Ma lo studente non è un bambino o un ragazzo che, tra le altre cose, studia: l’essere studente non è un ruolo, non è un mestiere, non è negotium ma è l’essenza del giovane, la sua condizione di esploratore della vita e della conoscenza, il farsi della sua acculturazione. I genitori che si lagnano dei compiti a casa perché sono un fastidio per loro, perché tolgono tempo allo sport o a Mc Donald, perché i bambini hanno diritto di correre, di giocare, di stare all’aria aperta non fanno una piega se quegli stessi bambini sono segregati a scuola dalle 8, 30 alle 16, 30. I genitori sono incoraggiati a delegare alla scuola la loro responsabilità educativa, rinforzati dai media che scaricano sulla scuola tutti i mali del mondo. Gli stessi genitori, che in forza dei famigerati Decreti delegati del 1974 sono «parte attiva di una comunità educante, organizzata democraticamente con organi collegiali che esaltano il ruolo e le competenze di ciascuna delle sue componenti». Ancora parole, tanta retorica e quale risultato? La verità è che se si confondono educazione e istruzione si fa un grande pasticcio. L’educazione è in sé una faccenda che riguarda la famiglia, le responsabilità genitoriali, i modelli di riferimento. Se vi sono in giro troppi medici o insegnanti o pubblici impiegati impreparati e incapaci di sostenere il loro ruolo sociale la responsabilità va giustamente attribuita alla scuola, al sistema formativo; ma se cresce il numero delle persone violente, dei disadattati, di quanti si arrendono di fronte alle difficoltà della vita la colpa non è della scuola ma di quella che, piaccia o no alla cultura dominante, è la cellula della società, la famiglia. Ma per ciò che riguarda il funzionamento della scuola dai Decreti delegati e dalla generalità dei provvedimenti presi sulla pubblica istruzione a partire dagli ultimi decreti del secolo scorso non gronda soltanto insulsa retorica fine a se stessa perché è da essi che è partito un sistematico attacco alla libertà di insegnamento, fondamento della libertà e dell’indipendenza della cultura. In forza di essi il potere amministativo, prima inesistente, ora annulla l’autorità professionale del docente ridotto al ruolo di impiegato, di lavoratore dipendente, e il preside, da primus inter pares che era, ora assurto nell’olimpo della dirigenza, si affretta a gettarsi dietro le spalle il suo passato, spesso infelice, di insegnante e diventa grazie all’autonomia un piccolo rasmentre il Collegio dei docenti, da lui diretto e convocato, non solo non conta nulla ma serve al ras come strumento per eseguire i propri diktat scaricandogliene addosso la responsabilità.
Il Sessantotto e la sua eredità Il Sessantotto fu per la scuola e per l’università una finta rivoluzione. Un’esplosione di violenza verbale e fisica, tanti slogan, rampolli della borghesia travestiti da operai, tanti muri imbrattati e, a parte lo sdoganamento del turpiloquio e l’avvento del tu, un unico risultato percepibile, che poi era forse l’unico obiettivo di tanto rumore: la rimozione degli ostacoli sulla via della laurea e della cattedra. Da allora concorsi universitari latitanti, lauree che non si negano più a nessuno – nessuno s’intende fra quanti si possono permettere di non lavorare e pagare le tasse universitarie – piani di studio liberalizzati perché fossero riempiti di insegnamenti inventati per gli amici e gli amici degli amici (e sai che ampliamento degli orizzonti culturali ne è seguito), ingresso nella scuola con corsi abilitanti umoristici e siccome non c’era posto per tutti, una massa di aspiranti destinati a ingrossare le file del precariato. Poi succede che quando si cerca di rimettere mano alla selezione non si è più in grado di raccapezzarcisi, non si resiste alla tentazione di truccare i concorsi, soprattutto quando il loro esito rischia di lasciare a terra gli amici e far decollare degli sconosciuti. Chi è un po’ addentro a queste faccende sa che cosa è stata la porcheria dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici e il caos di quello appena concluso per insegnanti, tutti con uno strascico di ricorsi che si protrarrà per anni. A farla breve: avevamo un’organizzazione di tutto rispetto, in grado di reggere il confronto con tutti i Paesi occidentali ed è stata colpevolmente distrutta. La prima a crollare è stata l’università, che ormai è un cumulo di macerie, poi è seguita la scuola secondaria, che ha visto la scomparsa della formazione professionale, anni di sperimentazione incontrollata in cui hanno sguazzato le scuole private, anche perché non è mai stata monitorata né seguita da verifiche, curricula alternativamente gonfiati e sgonfiati, riforme pasticciate, progetti e curvature, tirocini aboliti e al loro posto la trovata dell’alternanza scuola-lavoro, l’araba fenice della scuola, maturità sì e maturità no, commissioni esterne, interne, così e così, terza prova a corrente alternata e soprattutto una grottesca burocratizzazione fra pof, pei, pdp, pdm, rav, verbali, riunioni per materie, di dipartimento, di indirizzo, di plesso e un merito misurato con titoli che si comprano al suk dei masterifici. Burocratizzazione che si è abbattuta anche più violentemente sulla scuola media, che non si è mai ripresa dalla sciagurata riforma del 1960, quando vennero soppresse le scuole di avviamento professionale, e sulla scuola elementare, l’ultima a cedere sulla qualità della formazione che ha retto fino a tutti gli anni Settanta, quando ancora i bambini italiani si collocavano ai primi posti in Europa, per poi scivolare nella rovina generale, con la confusione dei tempi-scuola, l’inclusione improvvisata, gli effetti dell’invasione e gli stranieri nelle classi che hanno fatto il resto. I guasti delle ventate riformatrici Fatto sta che quanti, e sono la maggioranza, credono nelle istituzioni, tirano la carretta e ottemperano ai propri doveri almeno quanto rivendicano i propri diritti, è bene che stiano attenti alle trappole e alle mistificazioni della cultura dominante, che si rivela nel registro e nel ricorrente repertorio di vacuità. Quando, in un passato recente, tanti ciarlavano di comunità educativa – che operativamente non significa nulla – bisognava smascherarli e scoprire dove andavano a parare, quando blateravano sui diritti bisognava fargli dire che cosa intendevano e non consentire loro di trascinarci sul loro terreno fumoso e allusivo, quando battevano sull’autonomia e contrapponevano al modello verticistico, fatto, ohibò, di programmi uniformi, concorsi nazionali, controlli e gerarchia (ma, si ricordi, in quella scuola il professore era assolutamente libero) un modello orizzontale, “democratico”, bisognava farli uscire dal paravento delle parole, portarli allo scoperto, mettere a nudo la loro insipienza o la loro malafede. Se all’interno delle scuole non si fosse taciuto non avremmo ora questo pasticcio, questa confusione di competenze e di ruoli, genitori che si intromettono nelle scelte didattiche, che sono chiamati a esprimersi sui libri di testo, che sono strumento di lavoro dell’insegnante, e insegnanti che si intromettono nei problemi familiari, violando le più elementari regole di prudenza e riservatezza, e presidi, pardon, dirigenti, che della didattica se ne infischiano allegramente, badano solo alla facciata e, alla faccia dell’autonomia, si preoccupano essenzialmente di ottenere qualche privilegio per la piccola casta di cui si sono trovati a far parte. e alla quale agognano quelli che erano i segretari delle scuole, titolo terza media, e ora sono stati riciclati pomposamente come direttori dei servizi generali e amministrativi. Gerarchia per gerarchia era meglio quella di prima. Ecco perché, consapevole di dove ci hanno portato le grandi idee, quando leggo che la riforma “pessima” varata da Renzi prosegue sulla strada dello smantellamento dell’istruzione pubblica e che l’Italia ha il primato mondiale della femminilizzazione della scuola, mi chiedo dov’erano i signori che adesso scoprono l’acqua calda quando venivano zittiti quelli che si azzardavano a sollevare il problema nel momento in cui cominciava a manifestarsi. Ma soprattutto mi allarmo quando vedo come il fenomeno viene spiegato e quali correttivi vengono proposti da quegli stessi signori. È un po’ come il NO al referendum, che accomuna chi lo vuole per buttar fuori quel venditore di pentole che ci è stato imposto come capo del governo e le vestali di una costituzione nata vecchia che ci ha regalato le regioni a statuto speciale e la damnatio memoriae della nostra storia. Quelli che oggi si accorgono che la scuola italiana è allo sfascio, che la sua totale femminilizzazione è un sintomo della patologia che l’affligge, che l’insegnante è diventato un modesto operatore scolastico, che c’è un assurdo iato fra scuola secondaria e università, che nelle università c’è una nuova baronia che ha in comune con la vecchia la boria senza averne il prestigio e l’autorevolezza, sono gli stessi che imponevano gli esami di gruppo, il diciotto politico, la partecipazione e tutte le altre corbellerie che ci hanno portato al punto in cui siamo.
Che fare?
E al punto in cui siamo ci resta solo la rassegnazione? Penso proprio di no, anche perché niente dura per sempre e anche i periodi più bui finiscono. Il problema è da dove cominciare, se si vuole fare qualcosa. Mi verrebbe da dire che occorre prima di tutto smantellare la cultura che ha generato questo mostro ma questo è un obiettivo troppo ambizioso e troppo vago per poterlo perseguire. Bisogna tenerlo come stella polare e cominciare sottraendo la scuola alla morsa che la stringe fra i fautori della scuola azienda, della didattica innovativa, dell’invadenza della grande industria (renziani e ahimè anche belusconiani), e i fautori della scuola politicizzata, dell’inclusione, della non selezione, del nulla. Bisogna resistere alla tentazione di combattere gli uni alleandosi con gli altri perché sono entrambi la rovina della scuola, portatori di veleni differenti ma entrambi mortali, e pretendere che la scuola venga restituita in toto ai suoi legittimi proprietari, che sono i docenti e i discenti, e alla sua unica funzione che è quella di trasmettere il testimone della nostra continuità nazionale. Quindi, in concreto, da dove cominciare? Con l’imporre alle università un riordino che le porti ad un livello scientifico e didattico decoroso perché si possa disporre di laureati preparati e scegliere fra questi i migliori da indirizzare all’insegnamento; chiudere la stagione del precariato e delle liste d’attesa: chi vince un concorso entra, gli altri pensino ad un’occupazione e diversa, come si fa per tutti i concorsi: non è che chi non supera un concorso per entrare in banca diventa per questo un bancario precario; convincere l’opinione pubblica che il peggiore servizio che si possa fare ai giovani è quello di facilitare il loro percorso formativo: la severità e il rigore possono risultare sgradevoli ma sono la condizione per crescere sul serio; riprendere con decisione la strada che senza troppa convinzione era stata imboccata con la riforma Moratti: un canale per l’istruzione orientato verso le facoltà scientifiche e umanistiche e uno per la formazione orientato verso l’alta tecnologia. Ognuno poi faccia la propria parte e che Dio ci assista.
Pier Franco Lisorini è un docente di filosofia in pensione |