Mia vita, a te non chiedo
 Mia vita, a te non chiedo lineamenti
Mia vita, a te non chiedo lineamenti
fissi, volti plausibili o possessi.
Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso
sapore han miele e assenzio.
Il cuore che ogni moto tiene a vile
raro è squassato da trasalimenti.
Così suona talvolta nel silenzio
della campagna un colpo di fucile.
Il poeta dialoga con la sua vita. Egli non avanza richieste.
Semplicemente fa il punto della sua situazione rispetto all’interlocutrice.
Si ripete un po’ quello che accadeva in “Non chiederci la parola”, solo che là ad assumersi la parte di chi potrebbe essere il destinatario della richiesta del tipico “tu” montaliano, era il poeta stesso. Qui è la vita, che come la Natura in certe operette e in certe liriche leopardiane, neanche ascolta, e neanche sa di essere parte in causa. E’ in tutta evidenza, non più di una presenza funzionale, tanto che il poeta rinuncia ad acquisirne una risposta per quelle che sarebbero le sue esigenze esistenziali. Sarebbe persino più corretto dire che data per scontata la mancanza di qualsiasi feedback, si limita a confessare perché il suo animo è così rassegnato.
Sono stati tanti i tentativi di avere delle risposte. Sarebbe tempo sprecato insistere.
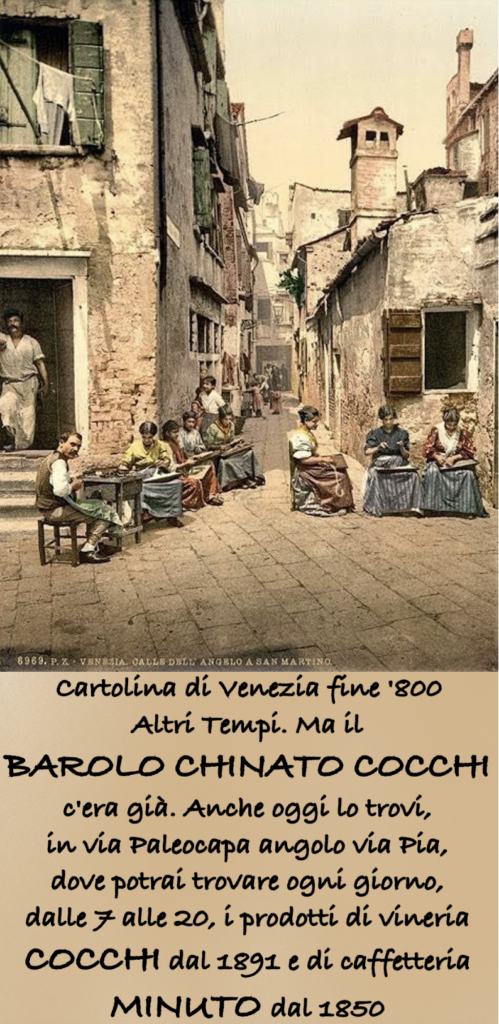
PUBBLICITA’
Esclusa un’ulteriore ricerca sulla vera e certa fisionomia (dentro e fuori) delle persone, ed esclusa altresì l’acquisizione definitiva (materiale e intellettuale) di qualcosa, perché esse stanno al di là delle possibilità reali dell’uomo e perché tutto è andato confondendosi nella mischia tra bene e male e persino piacere e dolore, resta da confessare la fotografia di che individuo resti dopo una simile resa.
La descrizione di essa la si trova nella seconda quartina, nella quale il poeta non fa parlare come nella prima la ragione, ma il cuore. Di sostanza e letteralmente, visto che essa inizia proprio con la parola “cuore”. Come dire: dinnanzi ad una situazione esistenziale tratteggiata nel modo che s’è visto, a livello emotivo cosa accade? Quale posizione assume, appunto, il cuore?
Ebbene, il cuore, tradizionale sede delle emozioni, ci viene presentato come colui (umanizziamolo sulla scia di quello che fa l’io-poetante) il quale di emozioni non ne ha (più), e che è giunto alla conclusione per cui le emozioni, che di per sé dovrebbero muovere e commuovere, sono vili, nel senso di disprezzabili, perché di dura cervice: non hanno ancora (si capisce che dietro c’è tutta una storia di tentativi, speranze, fallimenti e delusioni) capito che non vale la pena, che niente vale la pena affinché il moto del cuore provochi a sua volta il moto della persona per la quale batte.
Non è ammessa nessuna accelerazione, ma solo un’imperturbabile stoica, e perciò forgiata nell’esperienza della sofferenza, apatia.
Ciò non impedisce che in qualche occasione qualche cosa comunque penetri nelle maglie di una rete dalla quale se nulla più esce, di tanto in tanto può avvenire che qualcosa entri.
E ciò provoca un sussulto: per l’inaspettato ospite (pensiero, sentimento, paura, rabbia…) che coglie impreparati, e per il disappunto che qualcosa di “vile” reclami e occupi senza avere chiesto permesso un posto che si era deciso non doveva spettargli.
Il cuore “raro è squassato da trasalimenti”.
Non più abituato ad essere coinvolto, egli viene scosso perché è costretto a chiedersi se essere ancora soggetto al pungolo della realtà dopo essersene tanto staccato, non sia una sconfitta, un’autosmentita, uno sterile sacrificio del suo proprio tempo.
C’è tuttavia da chiedersi se il moto che il cuore tiene a vile sia solo del cuore, oppure se lo sguardo del poeta non sia rivolto anche e soprattutto all’esterno, a quelle cose per lo più vane e indaffarate le quali sanno con un colpo di coda smarcarsi per un attimo a causa di una sopravvenuta temporanea labile novità, stupire, e dunque indurre a trasalimenti sinceri.
Impossibili, in quanto istantanei, ad essere pensati, ma altrettanto impossibili ad essere accantonati.
Come il sopravvenire di un fulmine, che squarcia il buio, ma lo squarcia di luce.
A riprova il verbo “suona” che ci comunica come qualcosa rompa il silenzio in modo in qualche misura grato. Non è botto, echéggio, rimbombo, ma suono; anche se tanto più pericoloso (è provocato non a caso da un’arma che può ferire o uccidere) quanto più adescatore, come un canto marziale di sirena.
Esso ha infatti le sembianze della speranza messa in un angolo e lasciata lì da tempo per scelta e per constatazione, fino a che senza sceglierlo e senza nulla ragionare e dedurre, dall’esterno un ospite senza invito, un messaggero intruso, con la sua comparsa ha la prepotenza di rimettere in forse l’idea dolorosamente accumulata che non possano esistere “lineamenti / fissi, volti plausibili o possessi” (in altri versi montaliani rappresentati da “la bussola [che] va impazzita all’avventura e dal calcolo dei dadi [che] più non torna” e di lasciare col fiato sospeso.
I trasalimenti dunque squassano l’anima al pari di un colpo di fucile che interrompe il silenzio della campagna.
Ma è questione di attimi.
L’eco da lì a poco si spegnerà.
Il colpo, mancato o andato a segno, non lascerà tracce; coperto, ancora una volta, da una coltre di silenzio.
Caro Fulvio, sono veramente ammirato della tua acribia interpretativa e della tua acuta sensibilità estetica e poetica. Il tuo commento è quello di un poeta a un altro poeta., perché sai veramente intus-legere testi non facili come quelli montaliani.