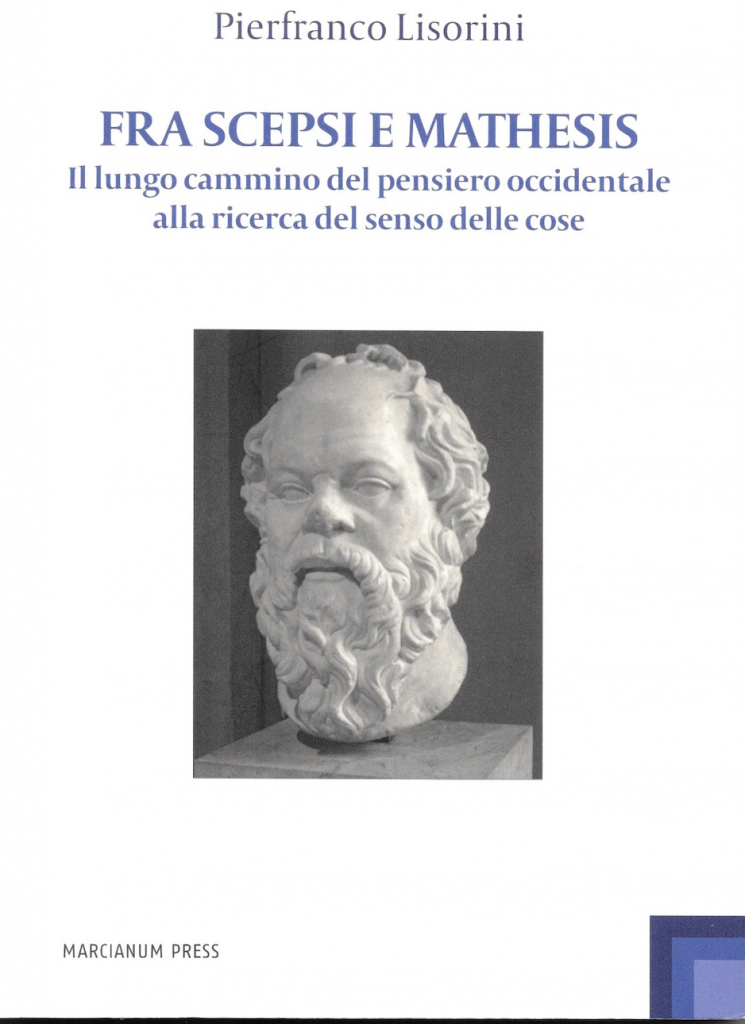Il mito della rivoluzione e l’inganno delle riforme. Come è stata distrutta la scuola
 Correre dietro alla moda è il modo migliore per rinunciare alla propria identità; fa il paio con l’ambizione, che è sbilanciamento verso il futuro, verso il non-ancora e smarrimento dell’hic et nunc in cui si è radicati. Così la smania di viaggiare, la sindrome delle vacanze, che tali non sono se non si va altrove, da qualche altra parte quale che sia purché lontana, il più possibile lontana. Diventa difficile vivere in situazione, che è l’unico modo del vivere autentico a patto che non si risolva nel giorno per giorno, nell’assenza di un percorso e di orientamento. Questo vale per gli individui ma vale ancor più per le comunità. Il mito della crescita, il concetto stesso di progresso sono nella loro essenza destabilizzanti, mettono in crisi l’omeostasi dei sistemi. Non che un sistema, che sia la coppia, la famiglia o la comunità nazionale, funzioni correttamente se è statico: al contrario, la stasi segna la fine del sistema: ma l’omeostasi in un sistema dinamico fa in modo che rimanga se stesso nel cambiamento, come l’acqua di una fiume e come la vita stessa. Si deve volere la ripetizione per integrare il cambiamento: solo con la conciliazione dell’essere e del divenire si garantisce la salute mentale delle persone e la vitalità delle istituzioni. Le rivoluzioni, la rottura della continuità sono un mito della modernità, che ne ha fatto un valore rovesciando l’antica diffidenza nei confronti delle res novae, portatrici di disordine e anomia. Un valore presente nel corredo assiologico di destra e sinistra, che non per nulla hanno attribuito una connotazione acriticamente positiva ad un evento come la fine violenta della monarchia francese, assurta a punto di svolta cosmico, palingenesi e riscatto dell’umanità intera, e continuano ad abusare del concetto spostandolo da un piano all’altro, dalla politica, alla letteratura, all’arte, alla scienza, alla tecnologia.
Correre dietro alla moda è il modo migliore per rinunciare alla propria identità; fa il paio con l’ambizione, che è sbilanciamento verso il futuro, verso il non-ancora e smarrimento dell’hic et nunc in cui si è radicati. Così la smania di viaggiare, la sindrome delle vacanze, che tali non sono se non si va altrove, da qualche altra parte quale che sia purché lontana, il più possibile lontana. Diventa difficile vivere in situazione, che è l’unico modo del vivere autentico a patto che non si risolva nel giorno per giorno, nell’assenza di un percorso e di orientamento. Questo vale per gli individui ma vale ancor più per le comunità. Il mito della crescita, il concetto stesso di progresso sono nella loro essenza destabilizzanti, mettono in crisi l’omeostasi dei sistemi. Non che un sistema, che sia la coppia, la famiglia o la comunità nazionale, funzioni correttamente se è statico: al contrario, la stasi segna la fine del sistema: ma l’omeostasi in un sistema dinamico fa in modo che rimanga se stesso nel cambiamento, come l’acqua di una fiume e come la vita stessa. Si deve volere la ripetizione per integrare il cambiamento: solo con la conciliazione dell’essere e del divenire si garantisce la salute mentale delle persone e la vitalità delle istituzioni. Le rivoluzioni, la rottura della continuità sono un mito della modernità, che ne ha fatto un valore rovesciando l’antica diffidenza nei confronti delle res novae, portatrici di disordine e anomia. Un valore presente nel corredo assiologico di destra e sinistra, che non per nulla hanno attribuito una connotazione acriticamente positiva ad un evento come la fine violenta della monarchia francese, assurta a punto di svolta cosmico, palingenesi e riscatto dell’umanità intera, e continuano ad abusare del concetto spostandolo da un piano all’altro, dalla politica, alla letteratura, all’arte, alla scienza, alla tecnologia.

https://tessere.org
E se in qualche misura il concetto di rivoluzione si è rivelato un’efficace chiave interpretativa, più spesso ha avuto un effetto distorsivo creando inesistenti discontinuità e rimuovendo, come nel caso della cosiddetta rivoluzione scientifica, interi percorsi protrattisi per secoli. C’è al fondo un errore epistemico e di metodo: le grandi trasformazioni hanno una lunga incubazione e in qualche modo è sempre possibile ritrovare nel passato che si ritiene superato non solo i germi o una larvata anticipazione ma la stessa realizzazione di ciò che appare nuovo e “rivoluzionario”.
Lo confesso: diffido delle rivoluzioni e quando sento parlare di riforme rabbrividisco, specialmente se si tratta di scuola. Ho vissuto impotente la sua sistematica distruzione. Mi laureavo quando i progressisti davano libero sfogo alla loro furia iconoclastica e riprendendo il fascista Bottai sopprimevano le scuole di formazione e di avviamento al lavoro imponendo la scuola media unica, che si rivelò da subito infinitamente peggiore della scuola media e delle scuole di avviamento di cui aveva preso il posto. La rovina della scuola media, privata un po’ alla volta del latino, trascinò con sé quella del ginnasio, anche per l’eliminazione dei filtri – doppio esame alla fine delle elementari, esame di accesso al liceo dopo la quinta ginnasio – che erano il terrore della borghesia e, di converso, garantivano l’ascensore sociale che consentiva il ricambio nelle professioni e metteva a disposizione degli uffici pubblici, dell’industria e della politica persone formate nella disciplina dello studio.

PUBBLICITA’
Ma la storia ci insegna che, almeno nel breve periodo, vincono i peggiori e il 68 ce ne ha dato una lampante conferma. Il problema è che la loro vittoria è andata ben oltre il breve periodo. La metastasi del riformismo ha investito anche l’istruzione superiore, non tanto per la discutibile introduzione della laurea breve quanto per l’okkupazione militare di tutte le facoltà realizzata dai compagni. I trombati alle elezioni o gli esclusi dalle candidature grazie al Partito una poltrona o uno strapuntino lo trovavano (e lo trovano) sempre, da dirigenti, da quadri o da gregari: nelle municipalizzate, negli enti locali e, il massimo dello status, nelle università: la parola d’ordine era lotta al baronato per far posto ai nostri ragazzi: quattro castronerie sulla resistenza e opla! una cattedra di storia contemporanea. Sono riusciti a far rimpiangere nepotismo e massoneria. Quel che è rimasto del vecchio impianto, in compenso, è l’assurda cesura fra licei e università; hanno voluto il continuum fra nido e scuola primaria, fra scuola primaria e istruzione secondaria di primo e secondo grado; poi stop, nessun raccordo con l’università e per garantire la cesura due ministeri diversi e soprattutto un salto retributivo insensato per i docenti. Intanto gli istituti professionali da triennali sono diventati quinquennali e si sono assimilati agli istituti tecnici e gli istituti tecnici si sono, si fa per dire, licealizzati, perdendo di fatto a loro specificità. Il colpo di grazia però l’ha inferto la sperimentazione che segnò la morte del liceo classico, diventato un indirizzo parallelo al socio-pedagogico che prendeva il posto dell’istituto magistrale, a un inutile linguistico e ad altri che si dividevano le spoglie del liceo scientifico e degli istituti tecnici. Un marasma, al quale si è cercato goffamente di porre rimedio con provvedimenti tampone, un marasma aggravato dalla contemporanea eliminazione del doppio criterio di selezione per aspiranti docenti: esami di abilitazione e concorsi a cattedre. Prima la buffonata delle graduatorie a esaurimento, il ripescaggio dei bocciati, i corsi abilitanti (un orrore: era praticamente proibito bocciare), poi l’interruzione dei concorsi e la loro sporadica ripresa sotto il ferreo controllo dei sindacati.
E, per aggiungere una nota comica, il lavorio parlamentare intorno a fumosi percorsi universitari per accedere all’insegnamento, che, se portati a termine, avrebbero comportato una formazione di nove anni per l’aspirante docente, s’intende dopo i cinque anni di scuola secondaria.

Progetto di riforma della scuola promosso da Giuseppe Bottai
Quattordici anni per fare il maestro quando il vecchio istituto magistrale formava in quattro anni eccellenti insegnanti, con alunni capaci di scrivere con sicurezza e con una grafia elegante e personale e di leggere un testo capendone il contenuto, un miraggio per le ultime generazioni.
Il colpo fatale alla scuola però non l’hanno data le riforme sulla struttura, sui percorsi didattici, sul reclutamento e la formazione del personale ma i decreti delegati varati nel 1974, che sancirono la partecipazione di genitori e studenti alla sua gestione. La scuola si regge anche sulla autorità e l’autorevolezza. A distruggere l’una e l’altra ci hanno pensato la lettera e soprattutto lo spirito dei provvedimenti che ne sono seguiti. Hanno portato alle pesanti interferenze nella gestione didattica e disciplinare, alle minacce a presidi e docenti, al dileggio, alla paura delle maestre processate quotidianamente nei capannelli dei genitori fuori della scuola, alla soggezione dei professori di fronte a giovani politicizzati, violenti o semplicemente stupidi.
 L’unica riforma seria per la scuola è una controriforma, una controriforma radicale, autenticamente reazionaria, antipedagogica, antipartecipativa, centrata sull’insegnante e finalizzata alla trasmissione delle conoscenze. Bisogna rimettere indietro le lancette dell’orologio, da quando gli studenti aizzati da cattivi maestri andavano in piazza contro la scuola classista, selettiva, compartimentata senza avere idea di come sostituirla. Si voleva cambiare ma si sapeva solo distruggere, si voleva svecchiare tagliando le radici e correndo dietro a utopie futuriste nascoste dietro la maschera della demagogia marxista. Ma la scuola coincide con le radici, garantisce la continuità, salvaguarda l’identità e la coscienza nazionali. Chi ha a cuore l’interesse del Paese dovrebbe impegnarsi per restaurarne l’impianto, rimetterla al centro della comunità e liberarla definitivamente del ciarpame sociopedagogico che l’ha soffocata. Gli ultimi sessanta anni sono stati il trionfo del metalinguaggio, delle chiacchiere campate per aria, della logorrea sulla valutazione – un problema inventato dai pedagogisti – delle dissertazioni su obbiettivi e finalità. È il momento di dire basta, di tornare al rigore – magari anche alla noia – dello studio e di mettersi in testa che la scuola è il luogo in cui si insegna e si impara. E prima del tablet, delle lavagne interattive, della digitalizzazione, prima della tastiera: carta e penna!
L’unica riforma seria per la scuola è una controriforma, una controriforma radicale, autenticamente reazionaria, antipedagogica, antipartecipativa, centrata sull’insegnante e finalizzata alla trasmissione delle conoscenze. Bisogna rimettere indietro le lancette dell’orologio, da quando gli studenti aizzati da cattivi maestri andavano in piazza contro la scuola classista, selettiva, compartimentata senza avere idea di come sostituirla. Si voleva cambiare ma si sapeva solo distruggere, si voleva svecchiare tagliando le radici e correndo dietro a utopie futuriste nascoste dietro la maschera della demagogia marxista. Ma la scuola coincide con le radici, garantisce la continuità, salvaguarda l’identità e la coscienza nazionali. Chi ha a cuore l’interesse del Paese dovrebbe impegnarsi per restaurarne l’impianto, rimetterla al centro della comunità e liberarla definitivamente del ciarpame sociopedagogico che l’ha soffocata. Gli ultimi sessanta anni sono stati il trionfo del metalinguaggio, delle chiacchiere campate per aria, della logorrea sulla valutazione – un problema inventato dai pedagogisti – delle dissertazioni su obbiettivi e finalità. È il momento di dire basta, di tornare al rigore – magari anche alla noia – dello studio e di mettersi in testa che la scuola è il luogo in cui si insegna e si impara. E prima del tablet, delle lavagne interattive, della digitalizzazione, prima della tastiera: carta e penna!
FRA SCEPSI E MATHESIS Il libro di Pierfranco Lisorini acquistalo su… AMAZON