VARIAZIONI SUL TEMA DELLA FELICITA’
|
VARIAZIONI SUL TEMA DELLA FELICITA’
I. La felicità degli antichi
|
|
VARIAZIONI SUL TEMA DELLA FELICITA’
I. La felicità degli antichi
|
|
Partiamo da alcune domande intorno all’essenza di quell’oggetto inafferrabile del (e dal) desiderio che chiamiamo felicità. Chiediamoci anzitutto: che cosa ci viene in mente quando pensiamo alla felicità? Ciascuno di noi ha un’idea di che cosa sia o possa significare la felicità, non fosse altro perché sa per esperienza che cos’è l’infelicità; quindi possiamo senz’altro dire che la felicità è il contrario dell’infelicità, ed è quella cosa che desideriamo o sogniamo sopra ogni altra quando siamo infelici, o semplicemente scontenti della nostra vita quotidiana.
|
|
Siccome però ciascuno è infelice a suo modo (non esiste un’infelicità astratta o disincarnata) anche la felicità sarà diversa per ciascuno, e avrà colori, forme (carne e sangue, direbbe Pavese) e significati propri a ciascun individuo, esattamente come ciascun individuo ha una fisionomia che lo distingue da ogni altro. La domanda filosofica, tuttavia, verte sul concetto, cioè sulla definizione e sul significato universale del termine “felicità”. Se cerchiamo sullo Zingarelli troviamo le seguenti definizioni: “s. f. 1. Condizione, stato d’animo di chi è felice o pienamente appagato. 2. Ciò che procura contentezza. Sin. Gioia. Contr. Tristezza. 3. (raro) Caratteristica di ciò che è del tutto adeguato, riuscito, opportuno”. In base alla prima definizione deduciamo che la felicità consiste nell’appagamento dei propri desideri: io sono felice nella misura in cui appago i miei desideri. Ma appagarli tutti è impossibile, anche raddoppiando o triplicando la durata media della vita; sarà allora sufficiente appagare un desiderio alla volta per raggiungere la felicità? Sia pure, e dopo? Voglio dire: una volta appagato un desiderio (e lasciamo per ora in sospeso la qualità del desiderio che viene soddisfatto) non avrò più niente da desiderare o, finita l’ebbrezza, non avrò pace finché non avrò appagato il desiderio (o il bisogno) successivo? Non è quindi inseguendo l’appagamento dei miei desideri che potrò essere veramente felice, tanto più che la seconda definizione ci dice che la felicità dipende solo in minima parte dalla nostra volontà o aspettativa: infatti è necessario che certi avvenimenti o certi felici incontri a lungo sognati o del tutto inattesi avvengano perché ci sia piena gioia e contentezza. La terza definizione è più pragmatica: denota la qualità di un lavoro ben fatto, di un’impresa che ha avuto buon esito, di una scelta azzeccata, di una capacità o abilità professionale giustamente riconosciuta, come quella di un bravo maestro di scuola, di un provetto artigiano, di un buon terapeuta, di un eccellente cuoco, di un campione sportivo, di un leader politico vincente, di un virtuoso del pianoforte. di un architetto di fama, ecc…E tanto basti per dar conto di come sia vana, qui come altrove, la pretesa di esattezza e di esaustività definitoria. Il termine felicità può quindi declinarsi in molti modi, ed è proprio quello che è avvenuto nel corso della storia, fin dai primordi del pensiero filosofico occidentale. E dalla felicità come era concepita nell’antichità greca e romana ha iniziato la sua conversazione il prof. Zaghi, nel secondo incontro del Caffè filosofico di Albenga, soffermandosi soprattutto sulla felicità-virtù di Socrate, Platone e Aristotele, e sulla felicità-piacere di Aristippo e di Epicuro.
|
|
La lingua greca distingue tra chi è felice per il possesso di beni materiali ed esteriori (olbios) e chi invece lo è intimamente (eudaimon); nel primo caso la felicità è quasi sinonimo di prosperità e di ricchezza, nel secondo ha a che fare con il daimon cioè con qualcosa che sta tra l’umano e il divino. Per Socrate non può esserci felicità interiore (eudaimonia) se non come conseguenza di una vita virtuosa; di qui la necessità di esercitarsi nel distacco dai beni materiali e del prendersi cura della propria anima per raggiungere la vera felicità, che non dipende dalle circostanze o dalla fortuna ma dalla conoscenza del bene. L’infelicità, in definitiva, come la malvagità, è il frutto dell’ignoranza.
|
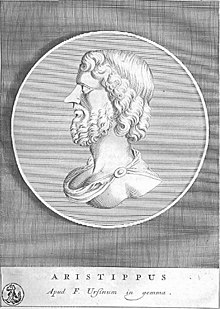 |
|
Anche per Aristotele il fine dell’uomo è la felicità, ma, diversamente da Socrate, ritiene che la conoscenza del bene, pur necessaria a una vita felice, non sia sufficiente: per raggiungere la felicità bisogna anche agire nel modo giusto e godere con misura dei beni e dei piaceri della vita, e si agisce nel modo giusto e si gode con misura dei beni e dei piaceri della vita quando ci si attiene al principio del “giusto mezzo” (mesòtes) tra eccesso e difetto, e ci si fa guidare, negli affari di questo mondo, dalla saggezza pratica (phrònesis). Non basta quindi l’agire in quanto tale per essere felici, bisogna che le azioni siano buone, cioè virtuose, e che costituiscano un ethos o abitudine costante di vita; quindi anche per Aristotele una vita felice è una vita virtuosa (e viceversa); inoltre così le virtù etiche (il coraggio, la temperanza, la generosità, la magnanimità. la mansuetudine…) come quelle dianoetiche (l’arte, la prudenza, la sapienza e l’intelligenza) non potrebbero né fiorire né esercitarsi fuori dalla polis, dal momento che l’uomo è un animale sociale, cioè politico, e, a differenza degli altri animali, ha la facoltà di parlare, e questa facoltà se non viene esercitata si atrofizza e se non c’è nessuno a cui e con cui parlare si finisce con il parlare, o meglio, con lo straparlare da soli come gli ubriachi e i pazzi. L’etica stoica si fonda sul riconoscimento della necessità e dell’universalità del logos che governa la natura della quale anche gli uomini fanno parte; la saggezza consiste quindi nel vivere secondo natura, e siccome in natura niente avviene per caso, il dovere del saggio è quello di non opporsi alla legge della ragione provvidenziale che governa il tutto, e che si configura quindi come destino, ma di accordare la propria vita individuale con l’armonia cosmica, che è sempre giusta
anche quando sembra che vada contro i nostri desideri: sbagliati sono i nostri desideri e le nostre passioni non l’ordine cosmico! E fin qui abbiamo brevemente parlato delle scuole filosofiche che identificano la felicità con la virtù; ma nel pensiero greco troviamo anche un’altra concezione della felicità, quella che la identifica con il piacere (hedoné), e che per questo è stata chiamata “edonismo”. Aristippo di Cirene e i suoi allievi, secondo quello che ne riferisce Diogene Laerzio, consideravano il piacere fisico e materiale il bene supremo; per loro tutti i piaceri immediati sono buoni, perché sono naturali, e i piaceri del corpo sono superiori a quelli esangui e pallidi dello spirito; anche i cirenaici tuttavia raccomandano la moderazione: mangiare, bere, dormire, copulare, sì, ma non troppo, se non si vuole che i piaceri fisici si trasformino in dolori. Per Epicuro, invece, i piaceri che procurano la felicità non sono quelli in movimento, che durano poco e lasciano sempre insoddisfatti, ma quelli stabili, cioè quelli che ci mantengono in uno stato di atarassia, che consiste nell’ assenza di ogni turbamento e di ogni dolore: “La voce della carne è: non avere fame, non avere sete, non avere freddo. Chi abbia queste cose o si aspetti di averle, può gareggiare in felicità con Zeus”. E può gareggiare con gli dei anche chi si libera dal timore della morte; non è difficile liberarsi da questo timore se ci si persuade che la morte è nulla per noi: quando ci siamo noi lei non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi… FULVIO SGUERSO
IL MIO NUOVO LIBRO
In vendita presso la libreria Ub!K di Corso Italia
La Locomotiva di via Torino
Libreria economica di Via Pia
|
