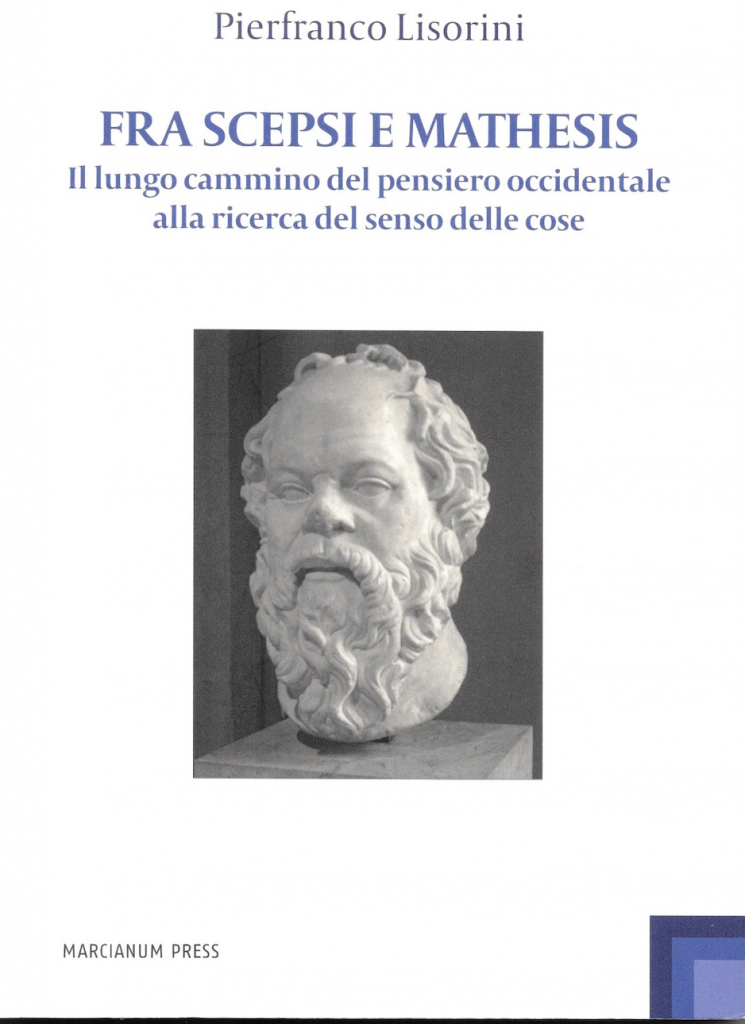Il mercimonio delle riforme
Dalla padella del riformismo di sinistra alla brace di quello di destra

Tajani, Meloni, Salvini https://www.repubblica.it/
Le riforme epocali sbandierate dalla Meloni e dai suoi scagnozzi, al di là del merito e dei punti di vista, nascono su un terreno viscido e malsano. La Meloni, che non sarà un’aquila ma è spinta dall’ambizione smodata di chi viene dal nulla, vede la possibilità di blindare il suo potere con un’investitura popolare ottenuta col 15% degli elettori; Salvini per mantenersi in sella deve pagare pegno ai nordisti della Lega bossiana; Tajani ha ereditato un conto in sospeso con la magistratura. Considerate in astratto le posizioni dei tre sono incompatibili: FdI e la Lega – chi non ricorda i cappi in Parlamento – hanno una tradizione giustizialista; FdI e FI sono contrari al larvato secessionismo della Lega; Lega e FI diffidano di una destra autoritaria e camaleontica. Ma quel che conta è che la Meloni si deve guardare da Tajani e da Salvini, che da un momento all’altro potrebbero far saltare il banco e l’avrebbero già fatto se non fosse che qualcuno oltreoceano ha ordinato all’establishment nostrano di proteggere la fedele atlantista ucrainomane. In queste condizioni risulta difficile esprimersi su provvedimenti che non nascono da una visione politica e da intimi convincimenti ma sono frutto di un mercimonio, sono scollegati fra di loro e al loro interno incoerenti.

https://www.lastampa.it/
L’elezione diretta del capo del governo ne fa automaticamente anche il capo dello Stato, a meno che non si avverta la necessità di mantenere una cariatide priva di qualsiasi autorevolezza. È vero infatti che la costituzione attuale lascia troppo spazio all’interpretazione dei poteri del presidente della repubblica ma comunque li si intenda essi hanno senso all’interno del perimetro istituzionale di una democrazia parlamentare, nella quale ad essere eletti sono solo i rappresentanti del popolo. Semmai è proprio il presidente della repubblica che potrebbe essere espresso direttamente dal popolo, nel qual caso il capo del governo avrebbe un ruolo subordinato di portaordini e il parlamento una funzione di controllo e le chiavi della borsa. A farla breve: ho l’impressione che la proposta del cosiddetto premierato (ma perché l’anglicismo?) non sia il risultato di una riflessione seria fra esperti di diritto costituzionale ma l’espressione della bulimia di potere della Meloni, inversamente proporzionale alla sua capacità di reggere il timone, e un modo per cautelarsi contro i suoi improbabili alleati senza dover ricorrere al sotterraneo appoggio della finta opposizione.

PUBBLICITA’
Sull’autonomia regionale assistiamo ad uno spettacolo grottesco. L’ente regione è stato il cavallo di battaglia dei comunisti fino dal 1945 e sono stati loro a imporla in costituzione tre anni dopo; gli stessi che a partire dal 1977 fino ad arrivare al 2001 con la riforma del titolo quinto della carta costituzionale – approvata con un referendum disertato dagli italiani – hanno pervicacemente attentato non tanto alla centralità dello Stato e alla sua matrice risorgimentale ma all’impianto organizzativo che garantiva competenze ed efficacia all’azione di governo con l’obbiettivo di mettere il potere decisionale e le relative risorse nelle mani della politica, vale a dire dei ras locali e delle lobby formatisi all’ombra del Pci e delle sue successive metamorfosi. Il decentramento amministrativo previsto dai costituenti aveva ben altre motivazioni: mirava a declinare le competenze dello Stato aggiustandole alle caratteristiche geografiche, agricole, manifatturiere delle diverse aree del Paese non a decentrare il potere politico. Ma in anni in cui il Pci non aveva alcuna possibilità di scalzare il potere della Dc e dei suoi alleati ed entrare nella “stanza dei bottoni” il controllo delle regioni “rosse” serviva ad imporre un potere alternativo, che di fatto si traduceva in una mangiatoia alternativa e nello strapotere della politica, vale a dire del Partito. Anche il regionalismo della Lega aveva come bersaglio lo stato risorgimentale sotto il profilo etico, politico e organizzativo – “Roma ladrona” era il leit motiv – ma nel caso della Lega prevaleva la volontà di liberare risorse soffocate dal peso della burocrazia romana per dare via libera alla capacità imprenditoriale del nord e alla sua apertura verso la mitteleuropa. Ora che la versione “leghista” del regionalismo sembra prevalere i compagni sono diventati centralisti, addirittura patrioti – quando i loro nonni mai ripudiati al canto di Bandiera rossa avrebbero ceduto anche Udine al compagno Tito – e in parlamento tentano di avvolgere il malcapitato Calderoli nel tricolore. Quindi tutto bene nell’Autonomia differenziata? Nemmeno per sogno. Il progetto leghista sposato dalla Meloni – e questo già dovrebbe metterci in guardia – per non tradursi in tanti centri di gestione di affari e malaffare, in venti bocche fameliche da imboccare, in venti gruppi di potere che ricalcano in piccolo il modello europeo e nazionale avrebbe bisogno di un personale politico affidabile che non esiste. Perché l’autonomia ha senso se corrisponde ad una esigenza della società civile e se si realizza il presupposto della coincidenza fra popolo e politeia. Marx aveva coniato la coscienza di classe, che è solo invidia sociale ed è un fattore distruttivo della compagine sociale, compattata dalla coscienza della propria sovranità, dalla condivisione di obbiettivi e dal senso di appartenenza. Senza di esse manca una rete di comunicazione interna alla società, mancano organizzazioni nelle quali si sviluppi una progettualità politica, mancano le persone disposte a mettere le loro competenze al servizio della comunità. In questo deserto c’è spazio per i cialtroni, per quanti percepiscono la politica come un ascensore sociale, come un mestiere che non richiede competenze di sorta, se non quelle di sgomitare, inchinarsi e tradire. In queste condizioni se c’è una via che porta al risanamento e alla credibilità delle istituzioni questa passa dal centro per poi irradiarsi nella periferia. L’idea che nella costruzione dello Stato la periferia precede il centro è priva di qualsiasi fondamento storico. Le regioni riflettono la malattia del centro: solo curando il centro si possono curare le regioni, che per dare respiro al Paese in questa congiuntura andrebbero quantomeno limitate nelle loro competenze lasciando nelle mani del centro settori che hanno bisogno di un intervento radicale come il sistema sanitario e la formazione. Tutto s’intende in via puramente ipotetica e subordinato ad un utopistico rivolgimento del quadro politico perché da chi oggi occupa il centro decisionale possono venire solo danni.

https://www.dire.it/
La terza riforma “epocale” del governo Meloni è quella della magistratura. Un’occasione sprecata, e non poteva essere altrimenti considerati gli attori. La giustizia italiana gode buona salute solo per gli stipendi dei suoi addetti, per il resto è la grande malata d’Europa e non solo per i tempi o per la carenza di personale. Al crescere della boria, degli emolumenti e del senso di impunità del giudice – che contrasta con le condizioni di tremore e timore in cui si trova a lavorare il medico italiano – sono diminuite di pari passo la stima e la fiducia dei cittadini, analogamente a ciò che è successo ai politici. Altro che separazione delle carriere: quel che serve è una rivoluzione antropologica, un radicale cambiamento di atteggiamenti che coinvolga la politica e la magistratura. L’una e l’altra devono recuperare lo spirito di servizio e il senso del loro ruolo.

Il Ministro Nordio
È significativo che l’associazione più rappresentativa dei magistrati per smentire la convinzione diffusa di stipendi abnormi pubblica in rete una tabella che li confronta con quelli di diplomatici, prefetti e dirigenti apicali dei ministeri quando invece dovrebbero essere rapportati a quelli delle altre professioni sulle quali si regge la collettività: medici e insegnanti. Un confronto impietoso che conferma la deriva delle istituzioni italiane verso un sistema autoritario con una gerarchia di status completamente stravolta rispetto al valore dei ruoli ma coerente con la convinzione maturata dai magistrati di far parte di un’élite, di un corpo privilegiato dell’apparato statale, gravato da una responsabilità esclusivamente morale – per chi l’avverte – dal momento che si è furbescamente scambiato l’indipendenza con l’impunità. Insomma, visto dalla parte dei cittadini e non dalle personali preoccupazioni dei professionisti della politica, il problema del malfunzionamento della giustizia civile e penale non è cero quello della separazione fra magistratura inquirente e magistratura giudicante.
Ci sarebbe un provvedimento di civiltà giuridica da prendersi immediatamente e senza costi: quello dell’abolizione dell’appello in caso di assoluzione; il secondo grado di giudizio, non parliamo del terzo, dovrebbe essere una garanzia per l’imputato non uno strumento di persecuzione giudiziaria.
FRA SCEPSI E MATHESIS Il libro di Pierfranco Lisorini acquistalo su… AMAZON