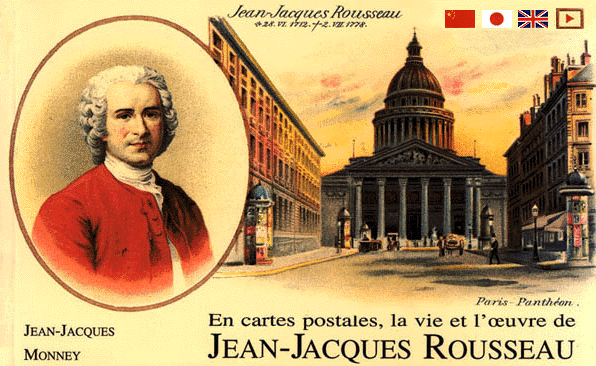La volontà generale tra democrazia e totalitarismo
|
La volontà generale
tra democrazia e totalitarismo
|
|
La volontà generale
tra democrazia e totalitarismo
|
|
Dal 1762, che è la data della sua prima edizione (e anche di quella del grande romanzo filosofico-pedagogico Emilio o dell’educazione ) Il contratto sociale o principi del diritto politico (da notare di passaggio che queste due opere furono condannate al rogo dal Parlamento di Parigi, dalle autorità ecclesiastiche e dal governo di Ginevra, costringendo il loro autore a fuggire all’estero per evitare la prigione) ha continuato e continua anche ai giorni nostri a essere considerato pietra della scandalo da teisti, conservatori, realisti, liberali e testo sacro da deisti, sognatori, democratici radicali e utopisti. Sulla fortuna – o sfortuna- di quest’opera grava ancora oggi l’accusa di aver fornito le basi ideologiche alla Rivoluzione francese e, in particolare, all’azione politica di Robespierre e dei giacobini sfociata nel Terrore e, in seguito, ai totalitarismi novecenteschi, cioè proprio l’opposto delle intenzioni pedagogiche e soteriologiche del pensatore ginevrino. Non per niente il Bonaparte di fronte al cenotafio del filosofo a Ermenonville dichiarò che, per la tranquillità della Francia, sarebbe stato meglio che quell’uomo non fosse mai esistito (al che vien fatto di pensare: da che pulpito viene la predica!). In ogni caso, Rousseau, da vivo come da morto, è sempre stato segno di contraddizione: illuminista sui generis privilegiò sempre le ragioni del cuore rispetto a quelle dell’intelletto calcolante tanto da attirarsi le critiche dei suoi colleghi e amici-nemici philosophes Diderot e D’Alambert, e soprattutto i sarcasmi di Voltaire sul tornare a brucare l’erba e a camminare a quattro zampe, sarcasmi offensivi oltre che gratuiti dal momento che lo stesso Rousseau riteneva impossibile il ritorno a uno stato di natura originario, peraltro solo ipotizzato, e non certo in quei termini: nel Discorso sull’origine della diseguaglianza l’uomo allo stato selvaggio è immaginato libero e in armonia con sé stesso e con la natura, per soddisfare le sue necessità non aveva ancora bisogno dei suoi simili con i quali tuttavia aveva in comune due sentimenti: l’amour de soi (istinto di autoconservazione) e la compassione per le sofferenze altrui, la pitié; inoltre, a differenza degli altri animali, possedeva due facoltà sue proprie: il libero arbitrio e la capacità di migliorare (o peggiorare) la sua condizione.
Ma tant’è questo pregiudizio riaffiora anche nella lettera commendatizia inviata da Federico il Grande di Prussia, il re filosofo, musicista e soldato amico di Voltaire e degli illuministi, al governatore di Neuchatel: “Bisogna aiutare questo sventurato, che ha il solo torto di nutrire opinioni singolari che però ritiene buone. Se non avessimo avuto la guerra e non fossimo in rovina, gli farei costruire un ermitage con un giardino dove potrebbe vivere così come crede che abbiano vissuto i nostri progenitori, anche se, per quanto mi riguarda le mie idee differiscono dalle sue quanto il finito dall’infinito, ed egli non mi persuaderebbe mai a brucare l’erba e a camminare a quattro zampe”(1). Di ben altro tono il giudizio che di “quello sventurato” diede l’altro suo collega e amico-nemico David Hume: “E’ simile a un uomo che si sia spogliato non solo dei suoi vestiti, ma della sua stessa pelle e che, in quelle condizioni, si sia buttato a combattere contro i violenti e tempestosi elementi che perpetuamente agiscono in questo basso mondo” (2). Le polemiche su di lui non si placarono neanche dopo la sua morte avvenuta nel 1778: “Io credo che se Rousseau fosse ancora in vita, in uno dei suoi momenti di lucidità, rimarrebbe attonito alla vista dell’effettiva follia dei suoi discepoli, che nei loro paradossi appaiono come suoi servili imitatori”, così scrive Edmund Burke nelle sue Riflessioni sulla rivoluzione in Francis (1790); per contro è nota l’ammirazione di Kant per il Ginevrino e documentabile l’influsso che esercitò sul giovane Goethe, sul romanticismo tedesco, sull’idealismo di Fichte e di Schelling (nonché sul pensiero e l’azione di pedagogisti come Pestalozzi e Froebel) e poi, tramite Hegel, sul pensiero dialettico di Marx e di Engels. D’altronde, come osserva Ernst Cassirer: “Il XVIII secolo, nella sua poesia come nella filosofia e nella scienza, s’adagia in un mondo formale fisso e finito e in questo mondo sente fondata la realtà delle cose, racchiuso e assicurato il valore di esse…Rousseau è il primo pensatore che, non solo pone in dubbio questa sicurezza, ma la scuote dalle fondamenta. Egli nega e abbatte, nell’etica e nella politica, nella religione, nella letteratura e nella filosofia, tutte le forme fatte che incontra” (3). Alla politica – ma questa, per il Ginevrino, non è mai nettamente separabile dalla morale, dalla storia, dall’educazione e dalla religione – dedica specificamente il Discorso sull’origine della diseguaglianza fra gli uomini (1754), l’articolo per l’Enciclopedia sull’ “Economia politica” (1754), il Contratto sociale (1762), il Progetto di costituzione per la Corsica (1768), le Considerazioni sul governo della Polonia e vari Frammenti politici pubblicati postumi. Con il suo Contratto Rousseau intende prospettare una nuova teoria del fondamento e del fine dell’ordinamento sociale, cioè di quella che i greci chiamavano “politeia”. Come quella platonica anche la polis rousseauiana ha una funzione etico-pedagogica: si tratta di dar vita a una società di liberi e di uguali i cui componenti considerino il bene comune come il bene di tutti e di ciascuno, e in cui le leggi non vengano imposte da una qualche autorità esterna ma siano opera comune dei contraenti del patto sociale che vincola i singoli all’obbedienza delle medesime, in quanto le leggi sono a tutela della vita, della libertà e, aggiunge Rousseau, della legittima proprietà di ciascuno.
Nella breve introduzione al primo libro, in cui si tratta del passaggio dell’uomo dallo stato di natura allo stato civile e delle condizioni del patto sociale, l’autore dichiara quali sono le sue finalità: “Voglio cercare se nell’ordine civile può esservi qualche regola di amministrazione legittima e sicura, prendendo gli uomini come sono e le leggi come possono essere. Tenterò di associare sempre in questa ricerca ciò che il diritto permette con ciò che l’interesse prescrive, perché la giustizia e l’utilità non si trovino a essere separate. Entro in materia senza provare l’importanza del mio argomento. Mi si chiederà se sono un principe o un legislatore per scrivere di politica. Se fossi principe o legislatore non perderei il mio tempo a dire che cosa si deve fare; lo farei e me ne starei zitto. Nato cittadino di uno Stato libero e membro del corpo sovrano, per debole che possa essere l’influenza della mia voce negli affari pubblici, il diritto di votare su di essi basta per impormi il dovere di istruirmi in proposito. Felice, ogni volta che medito sui governi, di trovare sempre nelle mie ricerche nuove ragioni per amare quello del mio paese” (4). Purtroppo, come sopra abbiamo visto, il suo amore per Ginevra non è stato per niente ricambiato! Ma, a parte questa nota amara, è ammirevole come in poche righe Rousseau tocchi i problemi fondamentali di quella che Machiavelli chiamerebbe una Repubblica bene ordinata: come conciliare gli interessi privati con l’interesse comune, la giustizia con l’utile, cioè con l’economia e con il lavoro necessario alla vita di tutti, il dovere di partecipare agli affari pubblici non solo con il voto ma anche e soprattutto di istruirsi per poter contribuire attivamente alle discussioni e alle decisioni del “popolo sovrano”; in altri termini: a che cosa serve essere liberi se non si esercita questa libertà per migliorare la nostra vita e quella del nostro prossimo, quindi di tutta la comunità (cioè del popolo), nei limiti delle leggi che noi stessi ci siamo dati? Senonché chi ci assicura che queste leggi siano giuste, dal momento che, come leggiamo all’inizio del primo capitolo del Libro Primo: “L’uomo è nato libero e ovunque è in catene. Chi si crede padrone degli altri è nondimeno più schiavo di loro”(5)? Questo folgorante incipit sembra quasi prefigurare la parabola del signore e del servo nella Fenomenologia dello spirito di Hegel e la dice lunga sul concetto che il Ginevrino aveva del mondo e dei tempi in cui gli era toccato di vivere.
Nel secondo capitolo riprende, in polemica con il giusnaturalismo di Grozio, gli argomenti del Discorso sull’origine della diseguaglianza ; trattando delle prime società afferma che “la famiglia è il primo modello di società politica; il capo è l’immagine del padre, il popolo è l’immagine dei figli, tutti essendo nati uguali e liberi, alienano la loro libertà solo per loro utilità. La differenza sta tutta nel fatto che nella famiglia l’amore del padre per i figli lo compensa delle cure che ne prende, mentre nello Stato il piacere di comandare supplisce a questo amore che il capo non ha per i suoi popoli” (6). Il passaggio, quindi, dalla società naturale della famiglia a quella artificiale e convenzionale dello Stato significa anche passare da una sottomissione volontaria a una involontaria o comunque imposta da un potere non naturale. Ma questo potere su che cosa è basato se non sull’obbedienza del popolo? E perché lo Stato si prenderebbe cura del popolo se non per blandirlo onde assoggettarlo e sfruttarlo meglio? Per contro “Grozio nega che ogni potere umano si fondi sul vantaggio dei governanti: cita l’esempio della schiavitù. La sua maniera più costante di ragionare consiste nel fondare sempre il diritto sul fatto. Si potrebbe forse usare un metodo più conseguente, ma non più favorevole ai tiranni. Dunque, secondo Grozio, non si sa bene se il genere umano appartiene a un centinaio di uomini, o se questo centinaio di uomini appartiene al genere umano, e in tutto il suo libro sembra incline alla prima opinione; la pensa così anche Hobbes. Quindi, ecco la specie umana divisa in branchi di bestiame, ciascuno col proprio capo che lo custodisce per divorarlo” (7). I riferimenti sono evidentemente al De iure belli ac pacis (1625) di Ugo Grozio e al Leviathan (1651) di Thomas Hobbes e al suo pactum subiectionis. Per Rousseau, così Grozio come Hobbes giustificano non la forza del diritto ma il diritto della forza; senonché il più forte “non è mai abbastanza forte per essere sempre il padrone, a meno che non trasformi la sua forza in diritto e l’obbedienza in dovere. Di qui il diritto del più forte, detto, in apparenza, diritto per ironia, ma in realtà stabilito come principio. Ma non ci spiegheranno mai questa espressione? La forza è una potenza fisica; non vedo quale moralità possa risultare dai suoi effetti. Cedere alla forza è un atto necessario, non volontario, al massimo è un atto di prudenza. In che senso potrebbe essere un dovere?”(8). Ecco la questione centrale del Contratto: può un popolo farsi volontariamente suddito di un sovrano come un individuo può volontariamente farsi schiavo di un altro individuo? La risposta di Rousseau è negativa. Un popolo che rinunciasse volontariamente alla propria libertà sarebbe un popolo di folli e sulla follia non si può fondare nessun diritto; nondimeno: “Un popolo, dice Grozio, può darsi a un re. Secondo Grozio un popolo è dunque un popolo prima di darsi a un re. Questo stesso dono è un atto civile, suppone una deliberazione pubblica. Pertanto, prima di esaminare l’atto per il quale un popolo elegge un re, sarebbe bene esaminare l’atto per il quale un popolo è un popolo.
Perché quest’atto, essendo necessariamente anteriore all’altro, è il vero fondamento della società” (9). Quindi il vero fondamento della società consiste in un patto sociale costitutivo di un corpo politico completamente nuovo, di una polis in cui valga il diritto contro il fatto, il progetto contro la casualità, il buono contro il cattivo o pessimo ordinamento civile. Per questo il vero patto sociale è un atto fondativo che dà vita a una società, anzi a un popolo basato sul diritto e sul dover essere, e, in ultima analisi, sulla virtù dei suoi membri. E così siamo giunti al capitolo sesto che tratta appunto del patto sociale o contratto, le cui clausole “si riducono tutte a una sola, cioè all’alienazione totale di ciascun associato con tutto i suoi diritti a tutta la comunità: infatti, in primo luogo, dando ognuno tutto se stesso, la condizione è uguale per tutti, e la condizione essendo uguale per tutti, nessuno ha interesse a renderla gravosa per gli altri” (10). In una società siffatta nessuno ha più motivo di temere di essere vittima di qualche sopruso o di qualche ingiustizia, quindi non c’è più bisogno né di avvocati, né di giudici, né di tribunali: “Infatti se i privati conservassero qualche diritto, poiché non vi sarebbe un superiore comune per far da arbitro nei loro contrasti con la comunità, ciascuno, essendo su qualche punto il proprio giudice, pretenderebbe ben presto di esserlo su tutti, lo stato di natura continuerebbe a sussistere e l’associazione diventerebbe necessariamente tirannica o vana” (11). Di qui la necessità di non derogare in nessun modo dalle clausole del contratto, pena il ritorno nella condizione servile e la perdita dei diritti e dei doveri acquisiti per mezzo del medesimo, il quale deve rimanere integro e uguale ovunque sia, anche tacitamente, ammesso e approvato. “Se dunque si esclude dal patto sociale ciò che non rientra nella sua essenza, vedremo che si riduce ai seguenti termini: Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi, come corpo, riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto” (12).Qui Rousseau ci sta dicendo che solo tramite la volontà generale si possono superare le diseguaglianze sociali tra gli uomini e perseguire insieme il bene comune e il godimento dei diritti di tutti e di ciascuno, ma ci dice anche il costo salato di questo superamento: l’alienazione totale di sé. Ci si aliena reciprocamente per ritrovarsi tutti insieme in un unico “corpo morale e collettivo, composto di tanti membri quanti sono i voti dell’assemblea, che trae dal medesimo atto la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà” (13). Ma che cosa dobbiamo intendere per “volontà generale”? Questo concetto viene meglio precisato nel capitolo terzo del Libro Secondo: “Da quanto si è detto consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica; ma non che le deliberazioni del popolo rivestano sempre la medesima rettitudine. Si vuole sempre il proprio bene, ma non sempre si capisce qual è; il popolo non viene mai corrotto, ma spesso viene ingannato e allora soltanto sembra volere ciò che è male” (14). Non sempre quindi, per il Ginevrino, vox populi significa vox Dei, e non bisogna nemmeno confondere la volontà generale con la volontà di tutti: “Spesso c’è una gran differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale; questa guarda soltanto all’interesse comune, quella all’interesse privato e non è che una somma di volontà particolari; ma eliminate da queste medesime volontà il più e il meno che si elidono e come somma delle differenze resta la volontà generale” (15). Questo significa che la volontà generale è presente in ogni uomo, anche in quelli che badano solo al proprio interesse privato, tutti aspirano infatti al bene e alla felicità, si tratta soltanto di fargliela riconoscere. “Se, quando il popolo informato a sufficienza delibera, i cittadini non avessero alcuna comunicazione fra di loro, dal gran numero delle piccole differenze risulterebbe sempre la volontà generale e la deliberazione sarebbe sempre buona.
Ma quando si formano delle consorterie, delle associazioni particolari alle spese di quella grande, la volontà, la volontà di ciascuna di tali associazioni diviene generale in rapporto ai suoi membri e particolare rispetto allo Stato; si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti sono gli uomini, ma solo quante sono le associazioni. Le differenze si fanno meno numerose e il risultato ha carattere meno generale. Infine, quando una di queste associazioni è tanto grande da superare tutte le altre, non avete più come risultato una somma di piccole differenze, ma una differenza unica; allora non c’è più volontà generale e il parere che prevale è solo un parere particolare” (16). Il pericolo maggiore per lo Stato è dunque la divisione del corpo sociale in consorterie, associazioni, corporazioni, ognuna con propri interessi particolari e spesso tra loro conflittuali. In conclusione: “Per avere la schietta enunciazione della volontà generale è dunque importante che nello Stato non ci siano società parziali e che ogni cittadino pensi solo con la propria testa” (17). Un solo corpo, quindi, formato da tutti i corpi dei cittadini, un solo popolo, una sola volontà generale, un solo io comune, una sola testa fatta di tutte le teste libere e pensanti degli associati? Non è chiaro come tutte queste frazioni possano formare un intero, un solo corpo morale e collettivo, un popolo sovrano e legislatore composto da cittadini in quanto sovrano e al tempo stesso da sudditi in quanto soggetto alle leggi che egli stesso si è dato. Riguardo a questo aspetto (sorvolo qui sulla intricata e insolubile questione delle caratteristiche morali attribuite all’uomo naturale pre-sociale e pre-politico) non sono mancate le perplessità e le difficoltà interpretative. Hegel, ad esempio, da un lato riconosce a Rousseau “il merito di aver sostenuto, come principio dello Stato, un principio che non soltanto per la sua forma (come, p. es. l’impulso di socialità, l’autorità divina), ma, pel contenuto, è pensiero, cioè il pensiero stesso, ossia la volontà”. Ma dall’altro lo critica perché “ha inteso la volontà soltanto nella forma determinata di volontà singola, e la volontà universale, non come la razionalità in sé e per sé della volontà, ma soltanto come l’elemento comune che deriva da questa volontà singola, in quanto cosciente; così l’associazione dei singoli nello Stato diviene un contratto, che, quindi, ha per base il loro arbitrio, la loro opinione e il loro qualsivoglia consenso espresso; e seguono le ulteriori conseguenze, prettamente intellettualistiche, che distruggono il divino in sé e per sé e l’assoluta autorità e maestà di esso” (18). Quanto a Marx, la sua critica riguarda l’identificazione dell’uomo vero e proprio nella figura del citoyen astratto, artificiale, figura allegorica di una morale anch’essa astratta, membro della società politicizzata, mentre l’uomo reale è riconosciuto solo nell’individuo egoista della società civile. Il patto sociale teorizzato da Rousseau è un patto tra gentiluomini che tutela la loro proprietà privata e l’eguaglianza dei diritti tra diseguali è funzionale agli affari e ai traffici della borghesia in ascesa. Da questo punto di vista Rousseau è veramente l’ispiratore della Rivoluzione francese in quanto rivoluzione borghese.
Su tutt’altro versante troviamo le interpretazioni “totalitarie” della volontà generale. Lo storico israeliano Jacob L. Talmon, nella sua opera Le origini della democrazia totalitaria (1952) distingue tra una democrazia di tipo liberale e una democrazia che egli definisce totalitaria. Si tratta di due forme di democrazia incompatibili una con l’altra. Queste due forme o correnti sono nate entrambe all’inizio del Settecento e hanno caratterizzato le vicende politiche della storia contemporanea fino ai giorni nostri. La differenza tra queste due correnti, secondo Talmon, non sta tanto nella loro diversa concezione della libertà quanto nel loro diverso atteggiamento riguardo alla politica stessa. Per i liberaldemocratici è una scienza empirica che procede per prove ed errori non ha un fine unico predefinito ma una concezione pragmatica dell’arte di governare; sostiene la tolleranza, il pluralismo e la libertà di pensiero e di religione, pensa che la politica è per l’uomo e non l’uomo per la politica, quindi riconosce che ci sono valori e qualità individuali e anche collettive completamente al di fuori della sfera politica. La democrazia totalitaria, invece, persegue un unico e ultimo fine e si basa su una sola e indiscutibile verità. Talmon definisce questa posizione ideologica “messianismo politico in quanto postula un insieme di cose preordinato, armonioso e perfetto verso il quale gli uomini sono irresistibilmente spinti e al quale devono necessariamente giungere, e riconosce infine un solo piano di esistenza, la politica. Tale orientamento estende l’ambito della politica fino ad abbracciare l’intera sfera dell’esistenza umana; considera tutti i pensieri e le azioni umane dotate di un significato sociale, e quindi inclusi nell’orbita delle azioni politiche. Le sue opinioni politiche non sono un insieme di precetti dogmatici o un corpo di espedienti applicabili a un particolare ramo dell’attività umana. Esse sono parte integrale di una filosofia onnicomprensiva e coerente. La politica viene definita come l’arte di applicare questa filosofia all’organizzazione della società e il fine ultimo della politica si raggiunge solo quando tale filosofia regna suprema su tutti i settori della vita”. E’ evidente la polemica di Talmon contro quei filosofi che credono possibile riportare il cielo (il paradiso) sulla terra e illudono il popolo semplice con la loro narrazione fascinosa ma irrealistica. Sono i filosofi che vogliono cambiare l’uomo e la società ma che, come è accaduto con la Rivoluzione francese, invece del cielo hanno portato il Terrore, la guerra civile e la miseria al popolo che intendevano liberare dal giogo del dispotismo e della paura. Tra questi, oltre ovviamente a Rousseau, Talmon indica fior di filosofi e scrittori come Claude-Adrien Helvétius, il sensista che dà tanta importanza al caso, oltre che all’ambiente, nell’educazione dell’uomo; Paul-Henri Holbach, il materialista rigoroso che considera la libertà del volere una pia illusione; Morelly, il poeta filosofo, autore del Naufragio delle isole galleggianti o Basiliade, in cui vagheggia un mondo felice senza proprietà privata; il nobile Gabriel Bonnot de Mably, che osò dichiarare revocabile il potere del re da parte del popolo…tutti pericolosi precursori della Rivoluzione francese e dei regimi totalitari. Quanto alla volontà generale di Rousseau, sarà pure sovrana, ma non lo è quella del popolo, corrotto dal feudalesimo e dall’egoismo derivato dalla proprietà privata. Di qui la necessità di essere guidato da chi sa qual è il suo vero bene. La società civile del Contratto sociale è un insieme atomizzato di individui. Questi si trovano come atomi del tutto indifferenziati di fronte al Potere: una massa informe senza distinzioni né categorie sociali come le classi o le corporazioni (non parliamo nemmeno di partiti e sindacati): la sovranità popolare non ammette corpi intermedi o rappresentanti. Una società corrotta va rifatta da capo. La volontà generale deve avere il potere assoluto necessario alla creazione di un ordinamento sociale completamente nuovo e poter eliminare tutti gli ostacoli che incontra sulla strada del Paradiso Terrestre. Alla costruzione di una nuova società è necessaria una religione civile, bisogna prendere dalla religione tradizionale il potenziale di mobilitazione e di fideismo sostituendo Dio con qualcosa d’altro, per esempio la nazione. Questo riguardo ai precursori del giacobinismo. Dopo di che Talmon prende in esame il comunismo di Babeuf e la fallita Congiura degli Eguali (maggio 1796), a dimostrazione della fine a cui vanno incontro gli inguaribili utopisti e i rivoluzionari esaltati.
Un’altra lettura critica del Rousseau politico è quella del filosofo cattolico del diritto Sergio Cotta, il quale, in uno dei saggi raccolti nel volume I limiti della politica, (il Mulino, 2002) mette a confronto il Ginevrino con l’autore dello Spirito delle leggi, rimarcandone la diversità di visione dei rapporti tra i cittadini e la politica. Nello studio su Rousseau, Cotta intende “mettere in luce il vicolo cieco nel quale finisce, in definitiva, il ragionamento di questo autore e, in sostanza, i limiti della politica come strumento di risoluzione dei problemi fondamentali dell’uomo”. Limiti che emergono chiaramente “da una discussione più attenta sui suoi scritti”. La posizione di Rousseau nei confronti della politica si caratterizza per due aspetti fondamentali: “Il primo – scrivono Thomas Casadei e Domenico Felice nel loro articolo Per una filosofia del limite. Sergio Cotta interprete di Montesquieu – riguarda l’impostazione gnoseologica e metodologica di fondo: se per Montesquieu lo studio della politica era essenzialmente diretto a comprenderla nella sua realtà e nelle sue leggi, per il Ginevrino la conoscenza è invece orientata a trasformare il mondo, a instaurare una società nuova che sani le deficienze di quella esistente. La filosofia di Rousseau, che su questo piano anticipa alcuni importanti sviluppi del secolo successivo, è veramente una filosofia come rivoluzione. Il secondo punto riguarda il posto della politica nell’esperienza umana; come si è già sottolineato, l’interesse preminente di Montesquieu per la politica non lo induce certo a disconoscere la rilevanza e l’autonomia di altre esperienze umane (a cominciare dalla religione ma non solo); in Rousseau, invece, una vera e propria primauté du politique, una concezione dunque che fa dipendere radicalmente dalla politica la risoluzione dei problemi dell’uomo. Inoltre, per Rousseau ‘essendo la società la fonte dello snaturamento e della corruzione dell’uomo dalla sua innocenza originaria, la salvezza deriva da un radicale cambiamento politico e dal prevalere della volonté générale che, esaltando il grand tout benefico e ordinato, nega la dialettica delle opinioni’. Dunque quanto di più lontano dalla visione montesquieuiana dei rapporti tra società e politica, nonché dall’articolazione pluralistica della società con le sue promanazioni partitiche”. Certamente per il cattolico Sergio Cotta la salvezza dell’uomo (e della donna, della quale stranamente nel Contratto sociale non si fa cenno) non può certo venire dall’instaurazione di un nuovo ordinamento politico o per opera della volontà generale.
Note 1. J. J. Rousseau, Opere , a cura di Paolo Rossi, Firenze, Sansoni, 1972, p.LXVI 2. Ivi, p.LXVI 3. Il problema Gian Giacomo Rousseau, Firenze, La Nuova Italia 4. Contratto sociale, a cura di Augusto Illuminati, Firenze, La Nuova Italia, p.3 5. Ivi, p. 3 6. Ivi, p. 4 7. Ivi, p. 5 8. Ivi, p. 6 9. Ivi, p. 7 10. Ivi, p.9 11. Ivi, p. 9 12. Ivi, p.9 13. Ivi, p.9 14. Ivi, p.20 15. Ivi, p.201 16. Ivi, p.20 17. Ivi, p.21 18. Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma Bari, 1974, p.240
Bibliografia CASSIRER Ernst 1968 Il problema Gian Giacomo Rousseau, La Nuova Italia, Firenze
COTTA Sergio 2002 I limiti della politica, il Mulino, Bologna
HEGEL Georg W. F. 1974 Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma Bari
ROUSSEAU Jean-Jacques 1980 Contratto sociale. Laterza, Roma Bari
TALMON Jacob l. 1967Le origini della democrazia totalitaria, il Mulino, Bologna
|