Alcune note su “Il canneto rispunta i suoi cimelli” di Eugenio Montale

Il canneto rispunta i suoi cimelli
nella serenità che non si ragna:
l’orto assetato sporge irti ramelli
oltre i chiusi ripari, all’afa stagna.
Sale un’ora d’attesa in cielo, vacua,
dal mare che s’ingrigia.
Un albero di nuvole sull’acqua
cresce, poi crolla come di cinigia.
Assente, come manchi in questa plaga
che ti presente e senza te consuma:
sei lontana e però tutto divaga
dal suo solco, dirupa, spare in bruma.
Il testo per il contenuto si divide in tre parti, con corrispondenza in ciascuna delle tre strofe.
Nella prima viene data una descrizione statica, nella seconda una descrizione dinamica, e nella terza, a consuntivo di ciò che le due strofe precedenti con la loro descrizione di valenza che travalica la fattualità suggerivano, una riflessione di tipo filosofico-sentimentale.
E’ una composizione equilibratissima. Piuttosto regolare anche formalmente, a parte quell’unico settenario posto a metà di una poesia tutta di endecasillabi, e a parte la rima imperfetta “vacua”-“acqua” che si inserisce nella serie di rime alternate nonostante la pronuncia scempia di vacua e quella doppia di acqua.
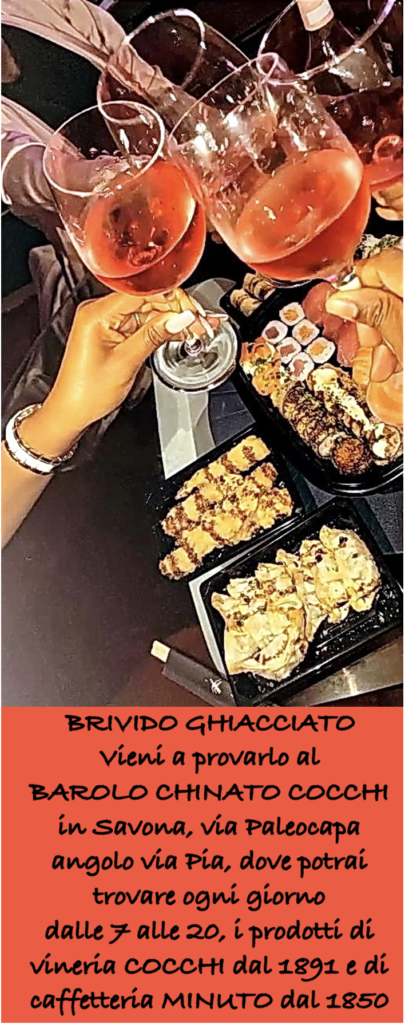
PUBBLICITA’
La rima imperfetta in metrica è contemplata, per cui da questo punto di vista averla utilizzata è più
che lecito (anche perché trovarne un’altra non sarebbe stato facile), ma nello specifico rende più ostico il contenuto. Infatti si tenga a mente, per esempio, il finale di “Gloria del disteso mezzogiorno”: / ma in attendere è gioia più compita / dove è capitale la positività che in esso riveste il tempo sospeso dell’attesa, per cui non è coerente nella parafrasi della lirica fermarsi a “vacua” come sinonimo di “vuota”, ovvero al primo e principale significato che gli attribuisce il vocabolario, ma bisogna attentamente contestualizzarlo. Cosa che avremo modo di fare tra poco.
Vediamo intanto l’ambiente com’è, come si trasforma, e come reagisce l’io lirico ad una trasformazione fisica che risulta alla fine fallimentare.
Siamo sempre nel solito ambiente essiccato che pervade ora più ora meno buona parte degli “Ossi”, e come al solito il sole è impietoso; ma l’incipit costituisce un po’ a sorpresa una nota positiva, perché sotto i raggi di questo sole che tutto asciuga e secca, e molto uccide, “il canneto rispunta i suoi cimelli”, pur nell’assenza di una prospettiva, in quanto lo fa nella “serenità” (termine la cui ambiguità tende ad irridere la speranza di un tempo dell’anima, appunto, sereno) che non dà, pare, segni di cedimento, drammaticamente riconosciuta e dichiarata da quei ramoscelli ormai privi di foglie che come braccia smagrite di prigionieri dietro le sbarre si protendono a implorare acqua al nemico.
Pare, s’è detto. Perché qualcosa accade: “Sale un’ora d’attesa in cielo, vacua / dal mare che
s’ingrigia. / Un albero di nuvole sull’acqua / cresce, poi crolla come di cinigia / “.
Ecco l’ulteriore e ultimo ribaltamento di fronte: “poi crolla come di cinigia”.
“Un albero”, da sempre simbolo di vita, “di nuvole”, ovvero di ciò che porta l’acqua, che cresce sull’acqua, complemento di luogo ma in questo contesto possibilissimo anche come complemento di causa e di origine considerato che gli ultimi due versi della seconda strofa sono il risultato di ciò che viene descritto nei primi due della medesima.
Vale a dire che la vita è data dal mare, metafisicamente contrapposto alla terra che ci imprigiona nelle sue categorie e che per farlo addirittura lo invade cercando di omologarlo ad esse: “Osservare tra frondi il palpitare / lontano di scaglie di mare”…
La solidificazione in scaglie della superficie del mare, rende perfettamente l’idea.
In esso sta il mistero; e soprattutto da lì ci può giungere non un rivelarsi dell’arcano, bensì la speranza di una speranza, un quasi-niente che consente tuttavia all’uomo di non crollare sotto il peso del vuoto di un albero di nuvole “come di cinigia”, cioè di cenere punteggiata coi rossi minutissimi residui roventi di fiamme consumate, che si sfalda.
Poteva essere cenere, perché cenere è la prima associazione di idee prodotta da un mare che sotto s’ingrigia, e da un albero di nuvole. Cenere perché finire in cenere è un tipo di figura retorica cristallizzata ad esprimere un fallimento, la catacresi della sconfitta.
Invece la straordinaria intuizione del poeta elegge un altro termine: cinigia.
Esso permette senza nessuna forzatura la rima, e poi ci dice come la speranza di quell’ora sospesa fatta di pioggia sospesa, sia sì diventata una cascata di cenere, ma di una cenere ancora calda, che ancora nasconde minuscoli lapilli, segno di una resa della speranza alla delusione difficile da accettare.
Esito di battaglia, non di guerra, la terra, orto assetato, non rinuncia ad attendere un altro albero, un’altra pioggia che la abbeverino dell’Assente. Chissamai!
L’ora, cioè il lasso di tempo che lascia sospettare un qualche cambiamento, viene definita, s’è visto, “vacua”, ed è aggettivo che, a ripresa di quanto preannunciato, nel contesto individuiamo come sinonimo di incerta, indecisa, in attesa di essere riempita da un evento. Che non avrà luogo; come certifica la situazione di una illusione seguita da una delusione espressa in modo icastico dai due verbi in sequenza contrastiva: “cresce, poi crolla”.
Poi, nell’ultima strofa, si apre un dialogo immaginario con un personaggio assente, che per l’appunto così, “Assente”, viene chiamato, facendo di un aggettivo un nome proprio.
E’ una donna (“sei lontana”), la donna amata (più perché attrae o più perché salva?), di cui il poeta lamenta la mancanza “in questa plaga” e che a causa del suo essere altrove muta il destino naturale degli eventi i quali, non calamitati da lei, si comportano alla stregua di una bussola impazzita che ha perduto il suo nord magnetico. Insomma la sua lontananza rompe le leggi dell’esistere, “e però tutto divaga / dal suo solco, dirupa, spare in bruma / “.
Precisare che “però” è forma arcaica di “perciò”, preferita forse perché “perciò” ha assunto col tempo una inflessione troppo deduttiva, e che “consuma”, pur inserito nella frase come verbo intransitivo, è di norma da intendersi transitivamente (cosa che nella parafrasi modificando la proposizione ma non il significato di essa, faremo) elimina due potenziali ostacoli alla comprensione della strofa.
Ma la vera difficoltà è rappresentata dall’espressione “ti presente“, perché vari fattori convergono, se la lettura non è più che attenta e avvertita, a rendere il testo incomprensibile.
E allora serve una chiosa: uno studioso di psicolinguistica direbbe che il termine “Assente” nella frase ha valenza di parola-chiave:
E’ scritto con la maiuscola.
E’ ad inizio frase.
Ha doppia funzione di aggettivo e di nome proprio.
E’ soggetto.
E’ enfatizzato dalla virgola che graficamente lo stacca e perciò evidenzia, e nella lettura costringe a pausare su di esso.
E’ il destinatario di un dialogo.
E’ nella logica del discorso un vocativo, e nella logica del messaggio, oggetto di una invocazione, e perciò nella relazione dialogica assume una posizione dominante.
Si direbbe addirittura che basti per farne la parola-chiave di tutta la poesia.
Lo diciamo perché a questo punto diviene molto arduo non sentire ancora l’eco di essa quando sei vocaboli dopo si incontra la parola “presente”, e automaticamente non farle fare il paio con “Assente” con cui per di più è in rima interna, intendendo tale binomio come una forma retorica oppositiva: la persona (che si vorrebbe) presente vs la (stessa) persona assente.
Tuttavia, come si è anticipato, il testo, letto in questo modo, è privo di senso, oltre a non tenere grammaticalmente.
Necessita un insight che dal piano della parafrasi ci immetta in quello della fonetica, e allora ci si rende conto così riposizionati, che il nodo da sciogliere sta nella…pronuncia della esse!:
Se infatti invece di pronunciare la esse di “presente” sonora com’è giusto quando fa aggettivo, la pronunciamo sorda, com’è giusto quando fa verbo, ecco che riusciamo subito a riprendere con coerenza le fila della lirica.
Dovremo allora intendere “che ti presente” nel senso “che ti pre sente”, “che ha presentimento di te”, “che sente qui la tua persona anche se ancora non ci sei”.
Ed ora una nota sulla parola “plaga”, letteralmente parte di un territorio piuttosto esteso e dai confini incerti. Termine aulico, ricercato. E se ricercato, certamente latore di un messaggio che non vuole limitarsi alla denotazione: in latino significa piaga.
Fuor di metafora: scegliendolo il poeta non avrà voluto confessarci che il luogo in cui si trova lo sente una ferita da cui non vede come potrà guarire se non con il farmaco della presenza dell’amata? Una presenza resa invadente dal desiderio: quando si desidera qualcuno contestualmente lo si evoca, lo si tiene presente prima che realmente lo sia; e la realtà plaga-piaga, orto, io lirico, poeta, Montale, partecipano alla consunzione di una simile realtà, fino a quando (e se) l’Assente non si smentirà per farsi Presente e giungerà a salvarli dalla bruma che in modo e quantità inversamente proporzionale al crollare dell’albero di nuvole, sta per opprimerli nel grigio della sua nebbia.
Amico mio, ad ogni nuova lettura sembra quasi che il tuo sguardo si acutizzi sempre più. Certo ti aita la sin-tonia sim patia che che ti lega al poeta degli Ossi di seppia, ma sin-tonia e sim-patia, da sole, non basterebbero a una lettura così stilistica e, al tempo stesso, così profonda del testo poetico. E’ come se lo facessi risuonare nello spaio della mente aggiungendo così nuove e ineditt sfumature di senso. E soprattutto ci porti con mano dentro il testo, in un dialogo sempre più intimo con le figure e le associazioni di idee scaturenti da un testo che contiene tesori inesauribili. Questo pre-sento e mi presento nell’attimo presente fissato come in una boccia di cristallo..